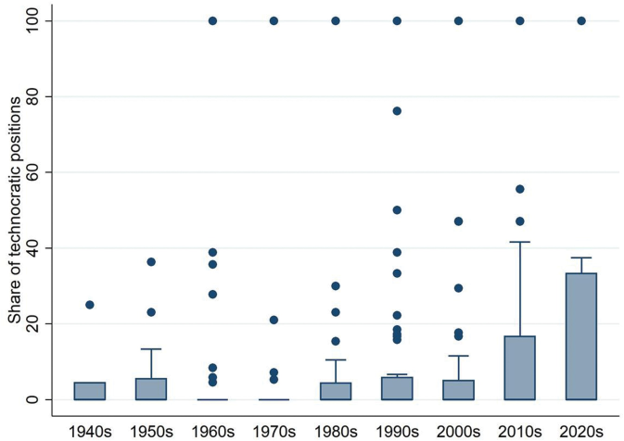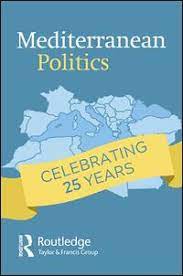Il primo turno delle elezioni amministrative appena conclusosi, restituisce l’immagine plastica di un paese sempre più sganciato dalle sue istituzioni rappresentative. Per via della loro natura “second order” (Reif e Schmitt 1980) rispetto alle politiche, le elezioni amministrative spesso scaldano poco il cuore degli elettori e per questo la partecipazione che vi si registra è di solito relativamente più bassa rispetto a quella delle politiche. Per quanto fisiologico e strutturato sia questo dato, non si può fare a meno di notare che la bassa partecipazione registrata domenica 12 giugno sia in realtà l’ultimo tassello (ultimo prima della prossima tornata elettorale) di un trend negativo che attraversa ormai l’Italia da anni (Trastulli 2021; Emanuele e Maggini 2016). Nel complesso degli 818 comuni al voto [1], la partecipazione elettorale è stata del 54,7%, ben 5,4 punti percentuali in meno rispetto alla precedente tornata di amministrative. Allo stesso modo, focalizzandoci sui comuni superiori ai 15.000 abitanti chiamati alle urne per rinnovare i propri organi di governo locale, il quadro che emerge mostra un significativo aumento dell’astensione (Tabella 1). Nello specifico, la partecipazione elettorale alle amministrative 2022 cala sia rispetto alle precedenti comunali (-5,8 punti percentuali) che, prevedibilmente, rispetto le politiche del 2018 (-17,2 punti). Le precedenti comunali avevano infatti registrato il 58,6% di affluenza, mentre l’affluenza di ieri si è fermata al 52,8%. Considerando le diverse aree del paese (Nord, “Zona Rossa” e Sud), si registra un calo rilevante nel Mezzogiorno nel confronto tra amministrative (-9,3 punti) e al Nord e Zona Rossa nel confronto tra amministrative 2022 e politiche, rispettivamente di 25,5 e 23 punti.
Guardando al confronto tra amministrative,
al Nord la partecipazione al voto per le precedenti comunali era stata del
54,6%. La percentuale si è ridotta per le amministrative 2022 raggiungendo poco
meno del 50%. La variazione di affluenza fra le consultazioni amministrative è
minore invece nella cosiddetta Zona Rossa, dove l’affluenza nelle precedenti
comunali era stata del 56,4%, mentre la partecipazione alla tornata elettorale
di ieri si è fermata al 52,5%. Dall’osservazione dei dati sulla partecipazione
elettorale nelle tre diverse aree emerge inoltre un aspetto interessante per
quanto riguarda il Sud. Come anticipato, il Mezzogiorno è l’area dove la
partecipazione è calata di più rispetto alla precedente tornata amministrativa,
con casi eccezionali come Palermo, dove l’affluenza si è fermata al 41,8%, il
valore più basso mai registrato nella città. Quest’area inoltre registra bassi
livelli di affluenza alle politiche. Tuttavia, si dimostra la principale zona
geografica per quanto riguarda la partecipazione alle comunali. Sia nelle
precedenti tornate che nel voto di ieri l’affluenza è stata maggiore al Sud che
nelle altre zone d’Italia. Si tratta di un dato coerente con quanto registrato
anche nelle amministrative di settembre 2021 (Trastulli 2021) e tendenzialmente
legato alle dinamiche di competizione elettorale locale fortemente incentrate
sul ruolo dei cosiddetti “signori delle preferenze”, che anche in
quest’occasione verrebbero dunque confermate (Fabrizio e Feltrin 2007; Emanuele
e Marino 2016).
Tabella 1 – Affluenza alle comunali 2022 nei 142 comuni superiori per zona geopolitica (%)
| | Affluenza politiche 2018 | Affluenza precedenti
comunali | Affluenza comunali 2022 | | Variazione dalle precedenti
comunali | Variazione dalle politiche 2018 |
| | | | | | | |
| 142 comuni superiori | 70.0 | 58.6 | 52.8 | | -5.8 | -17.2 |
| Nord | 74.7 | 54.6 | 49.2 | | -5.4 | -25.5 |
| Zona Rossa | 75.6 | 56.4 | 52.5 | | -3.9 | -23.0 |
| Sud | 64.7 | 65.3 | 55.9 | | -9.4 | -8.8 |
Volgendo lo sguardo ora ai comuni capoluogo e non (Tabella 2), si può notare l’esistenza, seppure non netta, di traiettorie diverse. Nei comuni capoluogo l’affluenza del voto amministrativo 2022 è stata del 50,1%, un calo pari a 5,75 punti rispetto al dato delle precedenti comunali. Nei comuni non capoluogo, invece, l’affluenza di ieri è stata maggiore (55,8%), come era accaduto già in occasioni delle precedenti consultazioni, dove la partecipazione elettorale aveva superato quota 60%. Il calo, tuttavia, è simile a quello dei comuni capoluogo, ovvero pari a -5,3 punti. Il trend che si registra in termini di differenza nell’affluenza tra capoluoghi e non capoluoghi conferma un andamento ormai strutturato se osserviamo precedenti consultazioni elettorali di livello amministrativo (Emanuele e Maggini 2016; Trastulli 2021).
Tabella 2 – Affluenza alle comunali 2022 nei 142 comuni superiori, per comune capoluogo (%)
| | Affluenza politiche 2018 | Affluenza precedenti
comunali | Affluenza comunali 2022 | | Variazione dalle precedenti
comunali | Variazione dalle politiche |
| | | | | | | |
| Capluogo | 68.8 | 55.9 | 50.1 | | -5.8 | -18.6 |
| No Capoluogo | 71.4 | 61.1 | 55.8 | | -5.3 | -15.6 |
Infine, i dati nella Tabella 3 mostrano l’affluenza in base alla condizione “incumbent” dei candidati. In altre parole, i dati indicano la partecipazione al voto nei comuni nei quali il candidato uscente si ripresentava alle elezioni oppure no. Anche in questo caso, il calo generale rispetto alle precedenti comunali e alle politiche del 2018 è confermato. La differenza tra comuni con incumbent e senza incumbent in termini di partecipazione al voto è assai ridotta. Nei comuni con incumbent si sono diretti alle urne il 52,3% degli aventi diritto, mentre nei comuni in cui non si presentava nessun candidato uscente la partecipazione è stata lievemente maggiore (53,4%). Osservando le variazioni percentuali, è possibile notare che il decremento più significativo nel passaggio dalle precedenti amministrative al voto del 2022 è riscontrabile nei comuni senza incumbent. Nello specifico, l’affluenza precedente era stata del 61%, ridottasi di 7,7 punti nel voto di ieri, che ha registrato un’affluenza pari al 53,4%.
Tabella 3 – Affluenza alle comunali 2022 nei 142 comuni superiori, per presenza di incumbent (%)
| | Affluenza politiche 2018 | Affluenza precedenti
comunali | Affluenza comunali 2022 | | Variazione dalle precedenti
comunali | Variazione dalle politiche |
| | | | | | | |
| Incumbent | 71.7 | 56.8 | 52.3 | | -4.5 | -19.4 |
| No incumbent | 68.3 | 61.0 | 53.4 | | -7.7 | -14.9 |
In generale, con un livello di partecipazione in netto calo rispetto alle precedenti amministrative e con un trend che sembra attraversare indistintamente l’Italia da Nord a Sud ormai da anni, l’astensione si conferma ancora una volta (come già in passato, Trastulli 2021) un vincitore assoluto di questa tornata amministrativa. Se combinato con il record negativo dell’affluenza registrato per il voto nei concomitanti referendum abrogativi sulla giustizia, il dato sull’astensione ci dice molto sull’attuale rapporto tra cittadini e politica, e su quelle che potrebbero essere le dinamiche del turnout in vista delle prossime elezioni politiche del 2023.
Riferimenti bibliografici
Emanuele, V., & Maggini, N. (2016). ‘Calo dell’affuenza, frammentazione e incertezza nei comuni superiori al voto’, in Cosa succede in città? Le elezioni comunali del 2016, V. Emanuele, N. Maggini e A. Paparo (a cura di), Dossier CISE, pp.49-56.
Emanuele, V., & Marino, B. (2016). ‘Follow the candidates, Not the parties? Personal vote in a regional de-institutionalized party system’. Regional & Federal Studies, 26(4), 531-554.
Fabrizio, D., & Feltrin, P. (2007). ‘L’uso del voto di preferenza: una crescita continua’, in Riforme istituzionali e rappresentanza politica nelle regioni italiane, A. Chiaramonte e G. Tarli Barbieri (a cura di), Bologna: Il Mulino, pp. 175-199.
Reif, K., & Schmitt, H. (1980). ‘Nine second-order national elections – A conceptual framework for the analysis of european election results’. European Journal of Political Research, 8(1), pp. 3-44.
Trastulli, F. (2021). ‘Comunali 2021: crollo dell’affluenza, vince l’astensione. Grandi città disertate, “tiene” l’effetto incumbent’, disponibile su: Comunali 2021: crollo dell’affluenza, vince l’astensione. Grandi città disertate, “tiene” l’effetto incumbent | CISE (luiss.it)
[1] Il dato si riferisce agli 818 comuni monitorati dal Ministero dell’Interno. Sono quindi esclusi i comuni di Sicilia e Friuli Venezia Giulia.