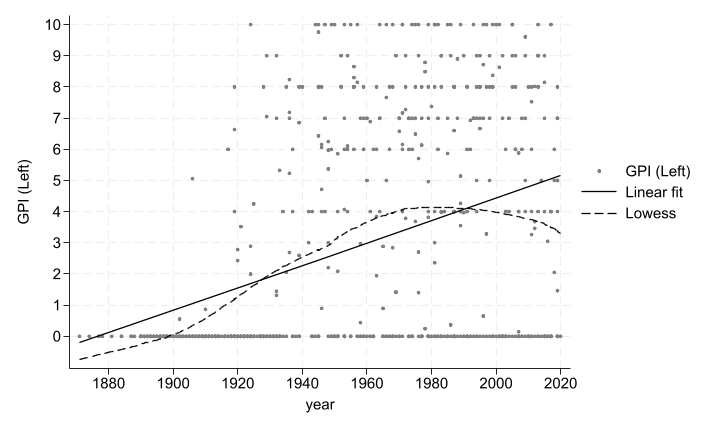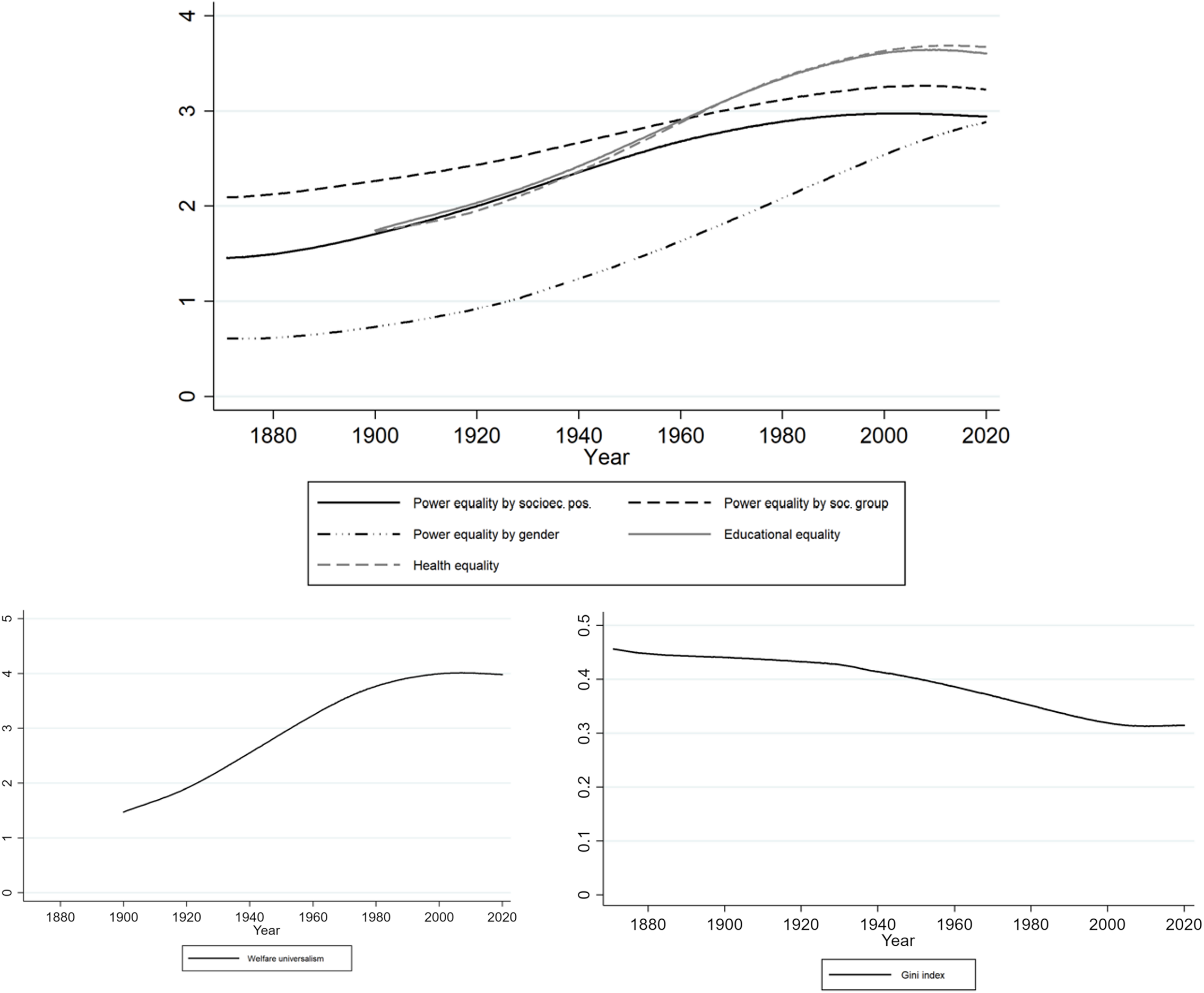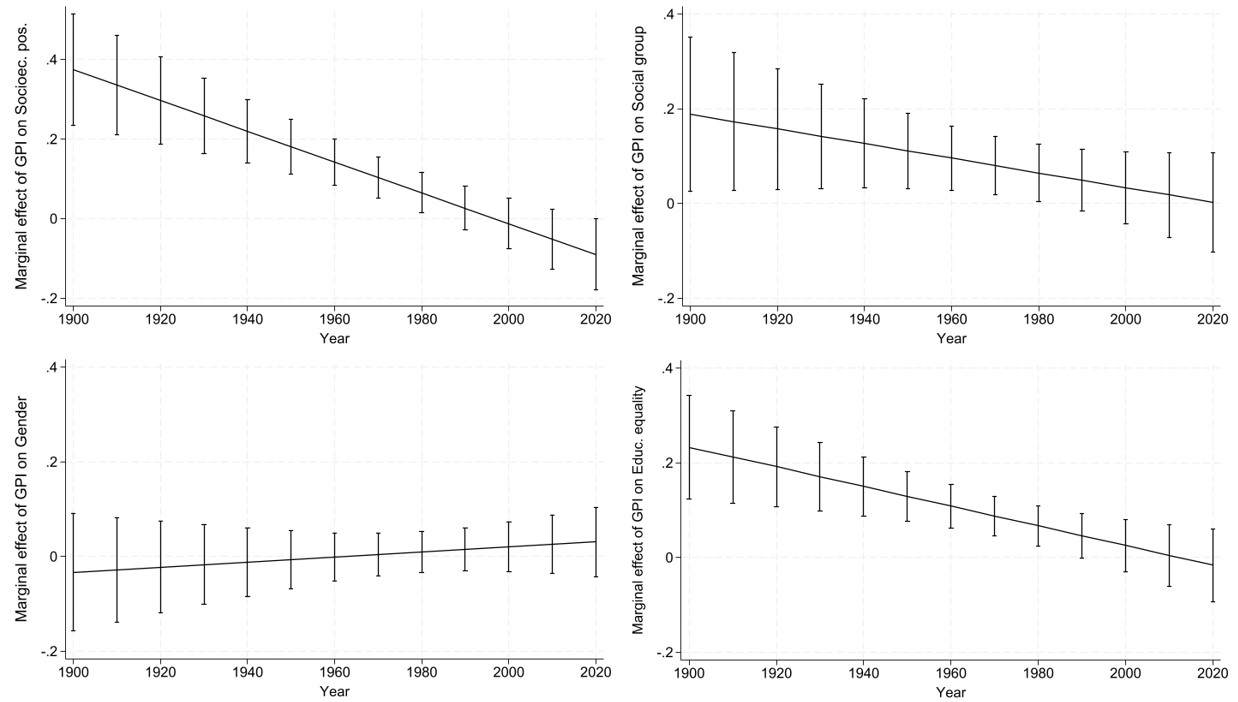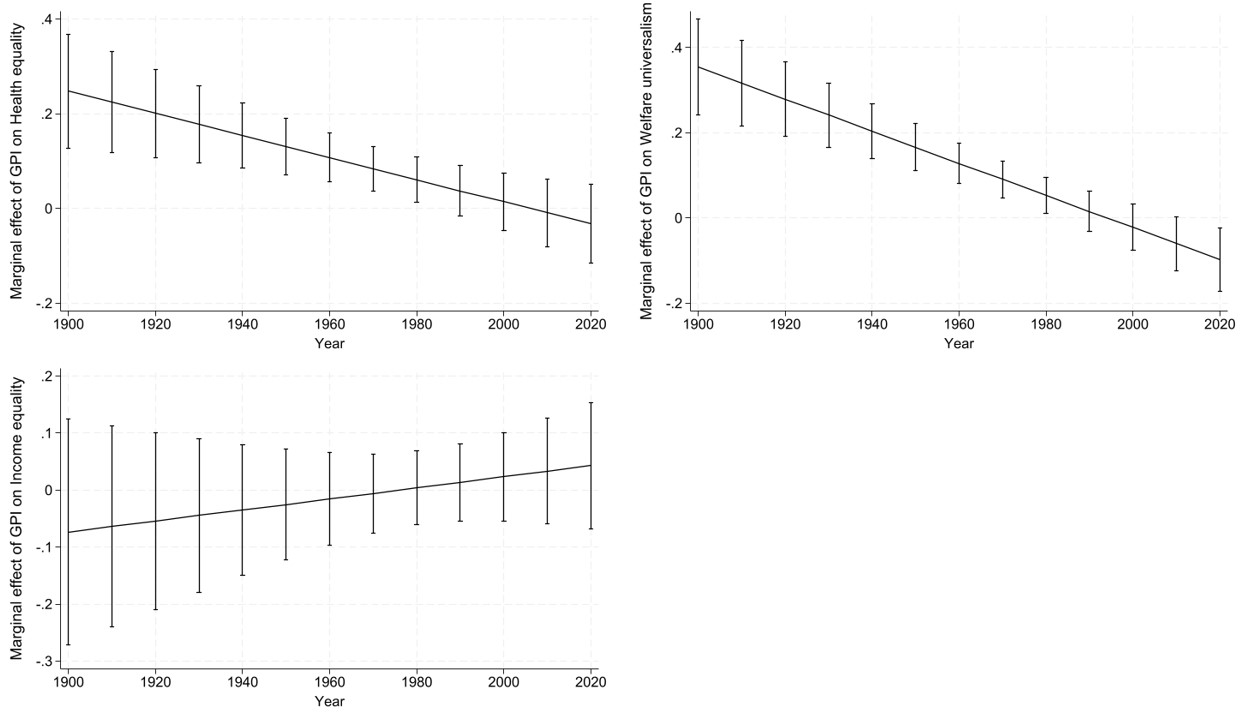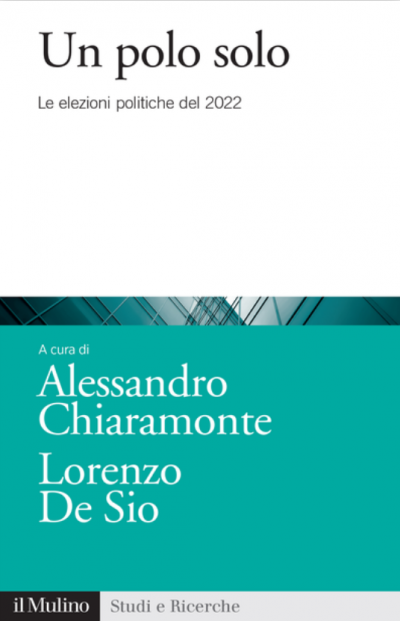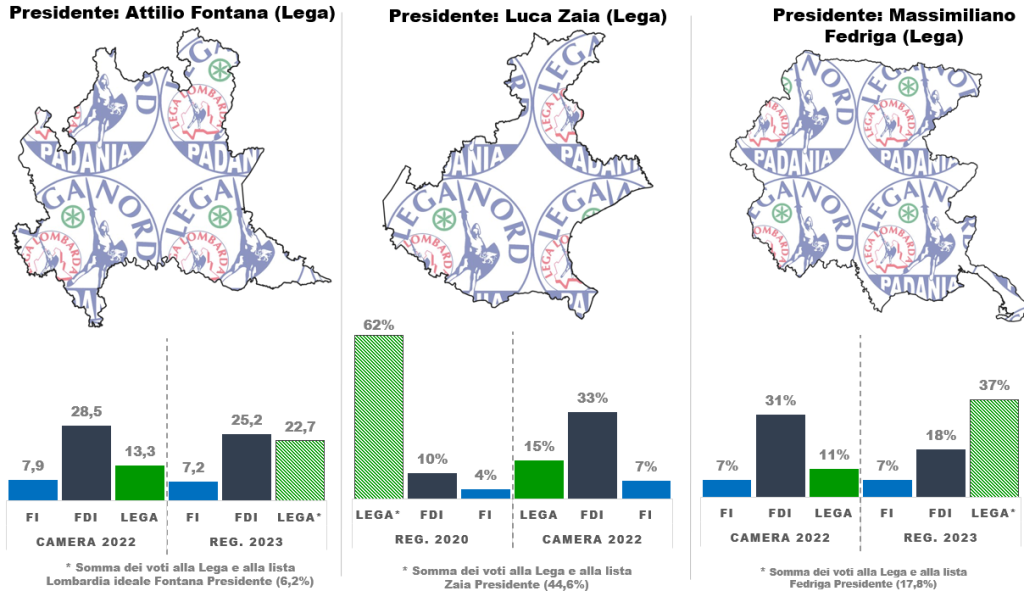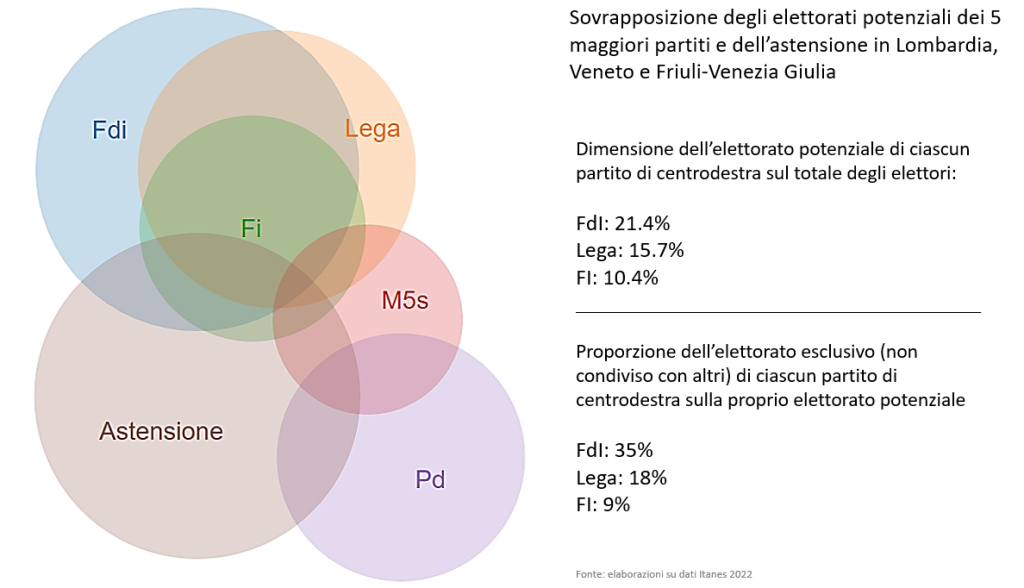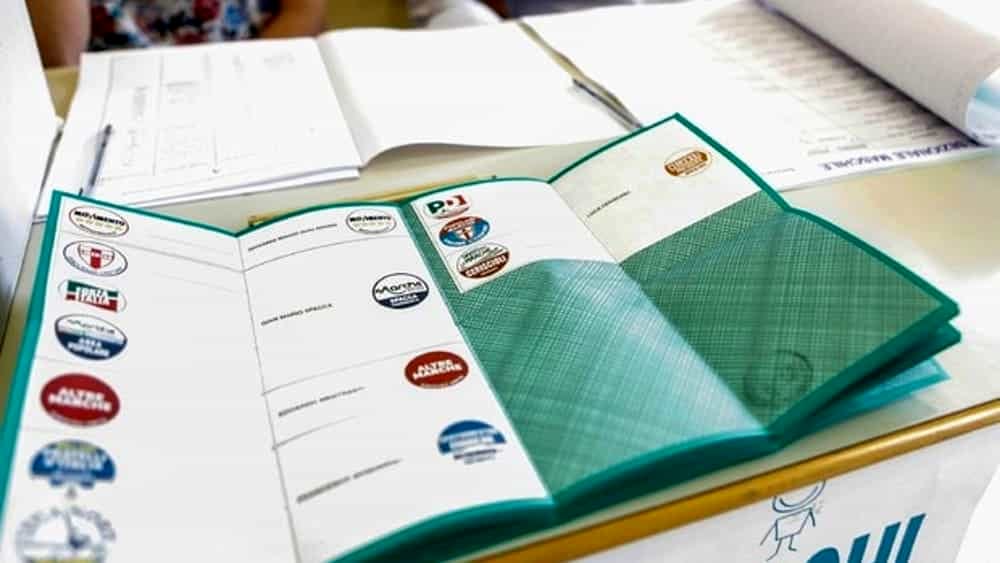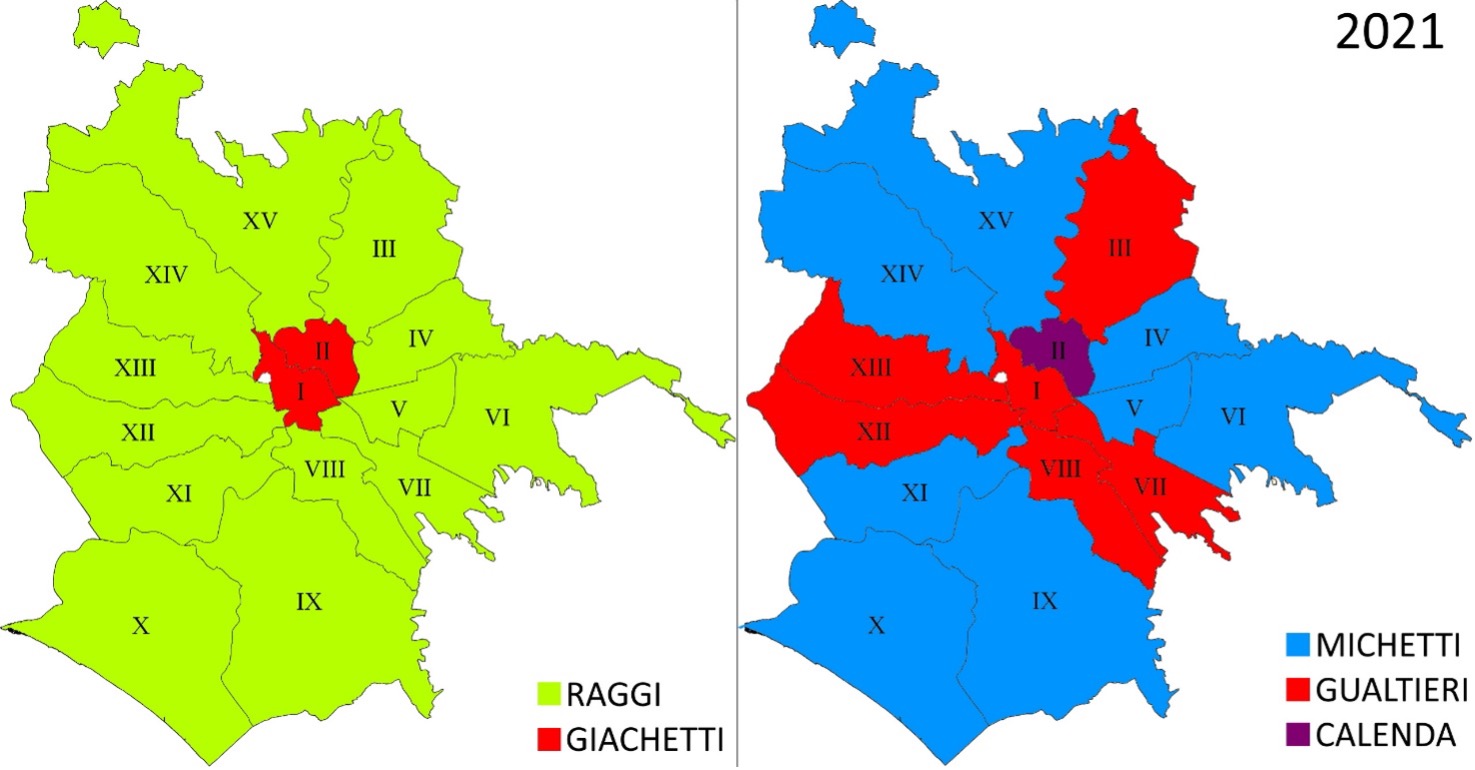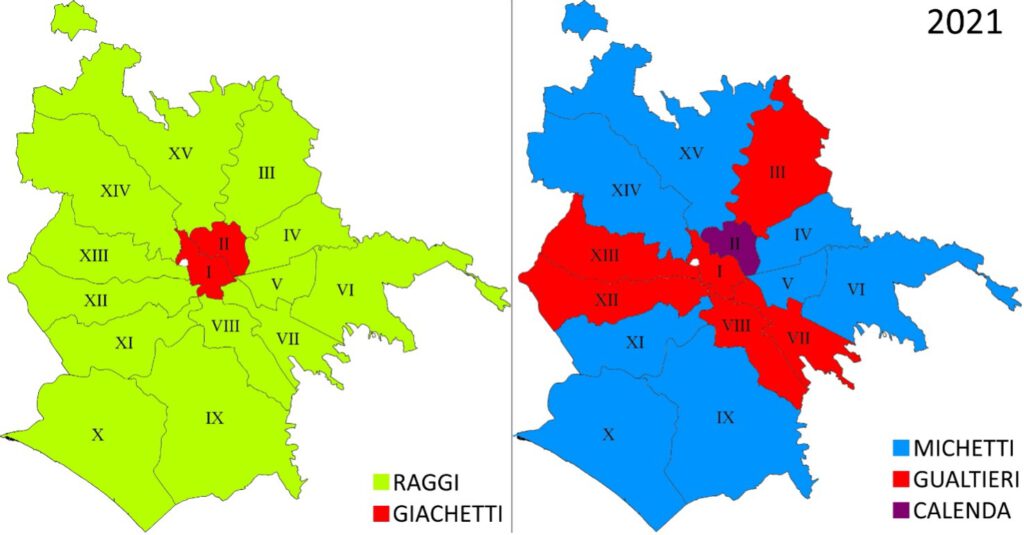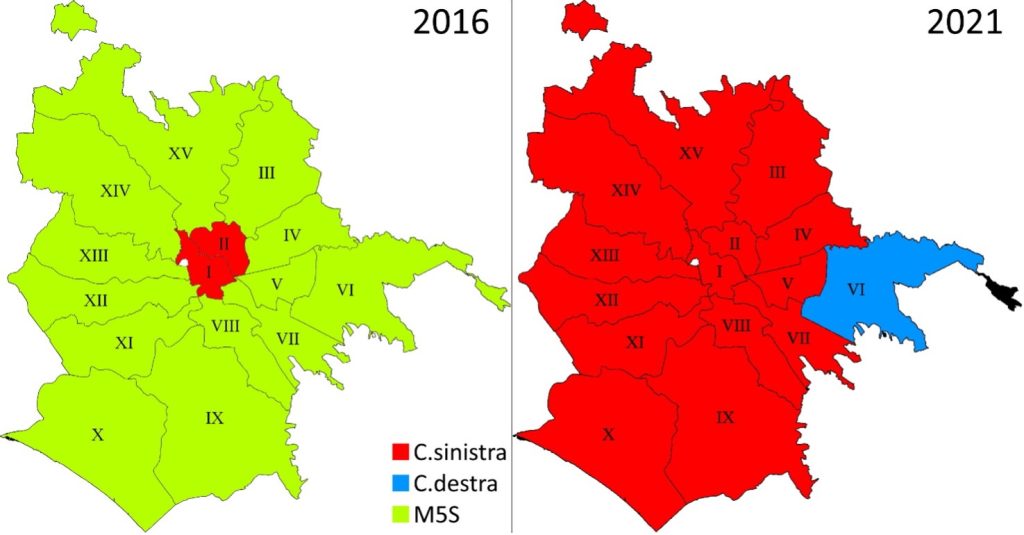di Mattia Gatti
Il concetto di sistema partitico de-istituzionalizzato fu introdotto negli anni Novanta da Mainwaring e Scully (1995) per inquadrare il costante stato di instabilità delle interazioni partitiche in America Latina. Esso si riferisce a una situazione in cui partiti politici instabili mostrano modelli d’interazione instabili e imprevedibili nel tempo (Casal Bértoa, 2014). Negli ultimi anni, tuttavia, questo termine è divenuto di utilizzo sempre più comune in Europa Occidentale. L’effetto combinato della crisi del debito europeo e di quella migratoria ha funzionato come catalizzatore per l’emersione di forze radicali e populiste di destra e di sinistra (Hooghe e Marks, 2018) che, cavalcando il crescente sentimento popolare anti-establishment, hanno politicizzato nuove linee di conflitto che vedono contrapposti i vincitori e i perdenti della globalizzazione (Kriesi et al., 2006). Di conseguenza, i tradizionali modelli d’interazione partitica europei ne hanno risentito, mostrando oggi una sempre crescente fluidità.
Tra le diverse realtà occidentali,
il sistema partitico italiano è probabilmente quello maggiormente influenzato
dalle recenti dinamiche politiche. Come sottolineato da Emanuele e Chiaramonte (2020), il periodo che segue
le elezioni politiche del 2013 rappresenta una delle fasi più instabile della
storia politica europea del dopoguerra, alla stregua di quanto avviene in
Francia (dal 2012), Islanda (dal 2013) e Irlanda (dal 2011). L’emersione di
nuove forze politiche (il M5S), e la trasformazione ideologica di altre (Lega)
(Albertazzi, Giovannini, e Seddone, 2018) ha portato a un aumento marcato dei
livelli di volatilità elettorale, innovazione parlamentare e governativa. Da
questo scenario fluido e confuso non si discostano i sistemi partitici
regionali, che nell’ultimo ciclo elettorale hanno assistito alla prepotente
affermazione delle liste dei candidati presidente (vedasi i casi di Luca Zaia e
Giovanni Toti), e al più generale indebolimento della leadership dei partiti
nazionali. Essi hanno perso la funzione di regolazione dell’offerta politica,
sempre più assoggettata ai voleri e all’influenza dei cosiddetti Campioni delle
Preferenze (De Luca, 2011). I Campioni delle Preferenze, identificabili come
quei candidati per i consigli regionali o locali capaci di ottenere un
consistente supporto personale (voti di preferenza), indipendentemente dal tipo
d’elezione o dal partito che li sostiene (De Luca, 2001), costituiscono dei
veri e propri partiti personali (Calise, 2000) a capo dei meccanismi di
reclutamento politico e sempre più fondamentali per la vittoria di un candidato
presidente e della coalizione a suo supporto.
Ci
si trova di fronte, insomma, a un sempre più marcato processo di ‘personalizzazione
decentralizzata’ (Balmas et al., 2014). Questa tipologia di
personalizzazione riguarda il trasferimento del potere politico dal gruppo
(esecutivo, partito) ai singoli attori politici (membri semplici di un partito,
parlamentari, consiglieri regionali e comunali), i quali acquisiscono maggiore
centralità e influenza nelle istituzioni, nei media, e soprattutto, nella
competizione elettorale, dove anche gli elettori sembrano essere sempre più
inclini a esprimere un voto per il candidato più che per il partito (Karvonen,
2010).
Seppur
la letteratura abbia evidenziato la crescente importanza dei Campioni delle
Preferenze come una specificità meridionale (De Luca, 2001; Napoli, 2005;
Emanuele e Marino, 2016), ci si può attendere che, data la crescente
instabilità e imprevedibilità generalizzata dei sistemi partitici regionali, i
Campioni abbiano accresciuto la loro influenza sulla competizione elettorale
anche in altre parti del paese. In sostanza, quella porzione del supporto
elettorale al candidato derivante dalla sua storia personale, dalle sue
qualità, attività e qualifiche (Cain et al., 1987) – ossia il voto
personale – sarebbe oggi uno (se non l’unico) dei principali elementi di
continuità dei sistemi politici regionali italiani. In particolar modo, il voto
personale sarebbe divenuto un elemento pervasivo delle due subculture politiche
italiane, quella rossa e quella bianca. Qui, la letteratura (Passarelli, 2017)
ha sottolineato il tradizionale ruolo del capitale sociale e
dell’organizzazione partitica nel prevenire la diffusione di un voto
prettamente personale. Tuttavia, gli ultimi decenni hanno evidenziato la profonda
crisi dell’impianto normativo e valoriale proprio della ‘Terza Italia’
(Bagnasco, 1977; Caciagli, 2011). La crisi economica e la generale disaffezione
verso la politica ha acuito la distanza tra partiti e comunità locale
(Valbruzzi, 2019), a tal punto che oggi è molto difficile parlare di un voto
d’appartenenza (Parisi e Pasquino, 1977). La conseguenza diretta di questi
processi è stata la marcata fluidità della domanda e dell’offerta politica.
Basti pensare che in Veneto l’ultimo ciclo elettorale ha fatto registrare una
volatilità elettorale del 37,9%, non dissimile da quanto registrato nello
stesso periodo in Campania (41,8%). Lo stesso si può dire dell’Emilia-Romagna,
fulcro della (ex) subcultura rossa, dove la volatilità elettorale ha raggiunto
il 33.2%.
È
quindi plausibile ipotizzare che in queste regioni la crescente pervasività del
voto personale abbia generato una nuova ‘sistematicità’, basata sulle
interazioni tra i Campioni delle Preferenze, e che queste risultino oggi più
stabili e prevedibili di quelle tra i partiti. Un candidate-based system –
cioè un modello di competizione elettorale basato sui candidati principali –
potrebbe aver integrato, se non sostituito, il classico modello di competizione
party-based, in cui sono i partiti a stabilire i legami con l’elettorato
e i candidati risultano solo una loro funzione. Per di più, la centralità dei
candidati potrebbe essere divenuta tale da determinare (predire) il successo o
la sconfitta di un candidato presidente e della coalizione a supporto.
Al
fine di cogliere questa nuova ‘sistematicità’ è necessario isolare quegli
attori individuali capaci di influenzare il processo politico regionale
nell’ultimo ciclo elettorale (2014/5-2020), vale a dire i Campioni delle
Preferenze, riproponendo il modello empirico utilizzato da Emanuele e Marino
(2016) nella loro analisi del caso calabrese. Si è quindi provveduto a
identificarli, operazionalizzandoli come quei candidati al Consiglio regionale
capaci di ottenere almeno l’1% di voti validi totali. Si è scelto di analizzare
tre diversi casi regionali, scegliendo come unità d’analisi la provincia/città
metropolitana[1].
Il primo caso è quello della Città metropolitana di Napoli (NA),
esemplificativo della ‘subcultura meridionale’ (Scaramozzino, 1990), dove
storicamente il voto personale ha rappresentato un elemento di raccordo tra istituzioni
e comunità. Inoltre, sono state selezionate la Città Metropolitana di Bologna
(BO), e la Provincia di Padova (PDV), rispettivamente centri importanti della
(ex) Zona Rossa e della ex Zona Bianca.
Si
può notare subito come, rispetto al caso emiliano-romagnolo e a quello veneto,
quello campano mostri una diffusione di grandi pacchetti di preferenze su un
numero maggiore di candidati (23 nel 2015 e 20 nel 2020). A Napoli i Campioni
delle Preferenze raccolgono il 31,7% dei voti validi totali nel 2015 e il 23.4%
nel 2020, mentre in Veneto e Emilia-Romagna non superano il 20% (dati non
mostrati). Seppur interessanti, questi dati non dicono granché sulla
possibilità di uno nuovo modello di competizione elettorale in queste regioni,
basato sui candidati e non sui partiti. Soprattutto, questi valori sono lontani
da quelli registrati nella provincia di Reggio Calabria da Emanuele e Marino
(2016), dove una trentina di candidati raccoglievano più del 60% dei voti
validi nelle elezioni regionali del 2010 e 2014.
Un’analisi
approfondita delle diverse interazioni tra i principali candidati, tuttavia,
fornisce un quadro sorprendente. Queste prendono la forma di ricandidature (con
lo stesso partito, con la stessa coalizione, con una coalizione diversa) ed endorsement
(per un candidato dello stesso partito, della stessa coalizione, o di una
coalizione diversa). In un party-driven system sarebbe logico attendersi
un’alta continuità nel supporto territoriale di un candidato candidatosi con lo
stesso partito a t e t+1, mentre questa diminuirebbe per un candidato che a t+1
cambi partito rimanendo nella stessa coalizione, e ancor di più per un
candidato che passi a un’altra coalizione. La stessa logica varrebbe per gli
endorsement. In un candidate-based system, invece, ci si potrebbe
attendere che i candidati – non essendo essi funzione del loro partito/lista – non
mostrino una sostanziale diminuzione della continuità del loro supporto territoriale
nel caso di passaggio a un partito o coalizione diversa, men che meno in caso
di endorsement. L’utilizzo di
correlazioni bivariate mostra, in questo senso, una notevole continuità con la
logica candidate-based. In tutte e tre i casi regionali, infatti, le
interazioni tra i Campioni sono caratterizzate da grande stabilità e
prevedibilità nelle interazioni (tabelle 1, 2 e 3). Emblematici sono i casi di Porcelli G. in
Campania (.95), Marchetti F. e Taruffi I. in Emilia-Romagna (.96), e Pan G. in
Veneto (.94). Ancora più rilevante è il fatto che la media totale delle
correlazioni ipotizzate tra i Campioni nelle diverse circoscrizioni sia
notevolmente più alta di quella tra i partiti (circa il doppio in ognuno dei
tre casi). In sostanza, ci si trova di fronte a un candidate-based system
che conferisce una maggiore stabilità e prevedibilità rispetto al tradizionale party-driven
system.
Tabella
1 – Supporto territoriale dei Campioni delle Preferenze e dei partiti in NA
|
Candidature
dei Campioni e endorsement
|
r di Pearson
|
Liste partitiche
|
r di Pearson
|
|
Amato V. (PD) -> (PD)
|
0,79***
|
Campania Libera -> Campania Libera
|
0,24*
|
|
Borrelli
F.E. (Davvero-Verdi) -> (Europa Verde-Demos Democrazia Solidale)
|
0,86***
|
Centro
Democratico-Scelta Civica -> Centro Democratico
|
0,19
|
|
Casillo M. (PD) -> (PD)
|
0,69***
|
De
Luca Presidente -> De Luca Presidente
|
0,28**
|
|
Casillo
T. (Campania Libera) -> (Campania Libera)
|
0,78*
|
Davvero-Verdi
-> Europa Verde-Demos Democrazia Solidale
|
0,38***
|
|
Ciarambino V. (M5S) -> (M5S)
|
0,79***
|
FI -> FI
|
0,39***
|
|
Daniele G. (PD) -> (PD)
|
0,24*
|
FdI -> FdI
|
0,20
|
|
Di
Scala M.G. (FI) -> (FI)
|
0,92***
|
M5S -> M5S
|
0,63***
|
|
Fiola C. (PD) -> (PD)
|
0,35***
|
PD -> PD
|
0,45***
|
|
Marciano A. (PD) -> (PD)
|
0,13
|
PD -> Italia Viva
|
0,25*
|
|
Marrazzo N. (PD) -> (PD)
|
0,74***
|
UdC -> UdC
|
-0,06
|
|
Porcelli
G. (Campania Libera) -> (Campania Libera)
|
0,95***
|
|
|
|
Raia L. (PD) -> (PD)
|
0,28**
|
|
|
|
Russo E. (FI) -> (FI)
|
0,64***
|
|
|
|
Nappi
S. (NCD-Campania Popolare) -> (Lega Salvini Campania)
|
0,47**
|
|
|
|
Schiano
di Visconti M. (FI) -> (FdI)
|
0,92***
|
|
|
|
Beneduce
F. (FI) -> (Campania Libera)
|
0,68
|
|
|
|
Guarino
F. (FI) -> (Italia Viva)
|
0,79***
|
|
|
|
Amente
M. (FI) -> Amente C. (FdI)
|
0,24*
|
|
|
|
Pizzella
F. (Centro Democratica-Scelta Civica) -> Manfredi M. (PD)
|
0,21*
|
|
|
|
Sommese
P. (NCD-Campania Popolare) -> Sommese G. (Liberaldemocratici-Moderati)
|
0,62***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Media
delle correlazioni ipotizzate (N:20)
|
0,63
|
Media
delle correlazioni ipotizzate (N:10)
|
0,30
|
Note: correlazioni bivariate (2015-2020)
attraverso i 91 comuni di NA; *p < .05, **p < .01, ***p < .001.
Fonte: elaborazione dell’autore.
Tabella
2 – Supporto territoriale dei Campioni delle Preferenze e dei partiti in BO
|
Candidature dei
Campioni e endorsement
|
r di Pearson
|
Liste
partitiche
|
r
di Pearson
|
|
Caliandro S. (PD) -> (PD)
|
0,49***
|
FI -> FI
|
-0,04
|
|
Marchetti F. (PD) -> (PD)
|
0,96***
|
FdI -> FdI
|
0,44***
|
|
Mumolo A. (PD)
-> (PD)
|
0,80***
|
Lega Nord-> Lega
|
0,44***
|
|
Paruolo G. (PD)
-> (PD)
|
0,82***
|
PD -> PD
|
0,85***
|
|
Taruffi
I. (SEL) -> (Emilia-Romagna CEP)
|
0,96***
|
PD ->Bonaccini Presidente
|
-0,13
|
|
Tomei
F. (SEL) -> Schlein E. E.
(Emilia-Romagna CEP)
|
0,36**
|
SEL -> Emilia-Romagna CEP
|
0.78***
|
|
Vannini
D. (PD) -> Donini R. (PD)
|
-0,05
|
|
|
|
Bignami
G. (FI) -> Lisei M. (FdI)
|
0,58***
|
|
|
|
Marsano
M. (PD) -> Felicori M. (Bonaccini Presidente)
|
0,58***
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Media
delle correlazioni ipotizzate (N:9)
|
0,61
|
Media
delle correlazioni ipotizzate (N:6)
|
0,33
|
Note: correlazioni bivariate (2014-2020)
attraverso i 55 comuni di BO; *p < .05, **p < .01, ***p < .001.
Fonte: elaborazione dell’autore.
Tabella
3 – Supporto territoriale dei Campioni delle Preferenze e dei partiti in PDV
|
Candidature
dei Campioni e endorsment
|
r di Pearson
|
Liste partitiche
|
r di Pearson
|
|
Boron
F. (Zaia) -> (Zaia Presidente)
|
0,32**
|
FI
-> FI-Autonomia per il Veneto
|
0,05
|
|
Marcato
R. (Lega Nord) -> (Lega Salvini)
|
0,53
|
FdI-AN-Altri -> FdI
|
0,05
|
|
Pan
G. (Lega Nord) -> (Lega Salvini)
|
0,94***
|
Lega Nord-Lega Salvini
|
0,09
|
|
Sandonà
L. (Zaia) -> (Zaia Presidente)
|
0,55***
|
PD -> PD
|
0,68***
|
|
Barison
M. (FI) -> (Lista Veneta Autonomia)
|
0,89***
|
Zaia -> Zaia Presidente
|
0,27**
|
|
Centenaro
G. (Lega Nord) -> (Zaia Presidente)
|
0,78***
|
|
|
|
Toffanin
R. (FI) -> Patron M. (FI-Autonomia per il Veneto)
|
0,05
|
|
|
|
Zanon
R. (FdI-AN-Altri) -> Soranzo E. (FdI)
|
0,21*
|
|
|
|
Ruzzante
P. (PD) -> Tognon A. (Il Veneto che vogliamo)
|
0,31**
|
|
|
|
Serato
L. (Lega Nord) -> Cavinato E. (Zaia Presidente)
|
-0,03
|
|
|
|
Piva
G. (PD) -> Vanni A. (Italia Viva-Civica per il Veneto-PRI-PSI)
|
0,30**
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Media
delle correlazioni ipotizzate (N:11)
|
0,44
|
Media
delle correlazioni ipotizzate (N:5)
|
0,23
|
Note: correlazioni bivariate (2015-2020)
attraverso i 101 comuni di PDV; *p < .05, **p < .01, ***p < .001.
Fonti: elaborazione dell’autore.
Ciò
nonostante, le analisi di regressione multivariata fanno propendere verso
maggiore cautela. Come mostrato dalla tabella 4 (è il caso esemplificativo di
Bonaccini in Emilia-Romagna), la capacità di predire il risultato elettorale
dei candidati presidente (e della coalizione a supporto) da parte dei Campioni
delle Preferenze (e dei loro pacchetti di voti) nelle diverse circoscrizioni è
significativamente minore di quello delle diverse coalizioni di partiti a
supporto dei candidati presidente. Infatti – come mostrato dai modelli 4 e 5 in
tabella – quando poste insieme la variabile relativa alla coalizione dei
Campioni e quelle concernenti diverse coalizioni di partiti, la prima diviene
(costantemente) statisticamente non significativa.
Tabella
4 – Voti per Bonaccini in 2020 predetti attraverso differenti aggregazioni di
coalizioni di partiti e Campioni delle Preferenze
|
Variabili indipendenti
|
Modello 1
| |
Modello 2
| |
Modello 3
| |
Modello 4
| |
Modello 5
| |
|
beta
|
s.e.
|
beta
|
s.e.
|
beta
|
s.e.
|
beta
|
s.e.
|
beta
|
s.e.
|
|
Coalizione di centro-sinistra nel 2014
|
0,80***
|
0.15
| | |
0,47**
|
0.24
| | |
0,52**
|
0.26
|
|
Campioni nel 2014 che supportano
Bonaccini
| | |
0,38**
|
0.42
| | |
0.05
|
0.30
|
-0.08
|
0.30
|
|
Dimensione demografica
| | | | |
0,23**
|
0.00
|
0,24**
|
0.00
|
0,22**
|
0.00
|
|
Tradizione politica
| | | | |
0,30*
|
0.08
|
0,61***
|
0.06
|
0,28*
|
0.08
|
|
Tasso di disoccupazione
| | | | |
-0.15
|
0.15
|
-0,25 *
|
0.17
|
-0.17
|
0.16
|
|
N
|
54
| |
54
| |
54
| |
54
| |
54
| |
|
R-quadro
|
0.65
| |
0.14
| |
0.74
| |
0.68
| |
0.75
| |
|
R-quadro corretto
|
0.64
| |
0.12
| |
0.72
| |
0.65
| |
0.72
| |
|
Statistica F
|
94.74
| |
8.54
| |
35.44
| |
25.56
| |
28.46
| |
Note: regressioni OLS con coefficienti
standardizzati (beta) ed errori standard (s.e.). *p < .05, **p < .01,
***p < .001.
Fonte: elaborazione dell’autore.
In
conclusione, questa analisi dimostra la crescente pervasività del voto
personale in sistemi partitici de-istituzionalizzati, o quanto meno turbolenti.
Lo studio delle suddette regioni evidenzia come le interazioni tra i Campioni
delle Preferenze abbiano generato una nuova sistematicità, caratterizzata da
una notevole stabilità e prevedibilità. In particolar modo, sembra che il voto
personale abbia recentemente assunto una funzione di ‘ancoraggio’ tra le
istituzioni e l’elettorato, proprio in quelle realtà a lungo dominate dalla
centralità e mediazione partitica. Nondimeno,
l’analisi della competizione presidenziale palesa una certa resilienza della tradizionale
competizione party-based. I partiti, in tutte e tre le regioni sotto
analisi, possiedono ancora un certo potere simbolico e identificativo, agendo
come euristiche per l’elettorato. La sfida presidenziale, in sostanza, dipende
ancora fortemente da essi.
[1] L’elezione dei candidati al
consiglio regionale avviene, infatti, su base provinciale.
Bibliografia:
Albertazzi, Daniele, Giovannini, Arianna, e Seddone,
Antonella (2018), ‘No regionalism please, we are Leghisti!’ The transformation of the Italian Lega Nord
under the leadership of Matteo Salvini, Regional and Federal Studies,
Vol. 28, No.5, pp.645-671.
Bagnasco,
Arnaldo (1977), Tre Italie: la problematica territorial dello sviluppo
italiano. Bologna: Il Mulino.
Balmas,
Meital et al. (2014), Two routes to
personalized politics: Centralized and decentralized personalization, Party
Politics, article first published online, https://doi.org/10.1177/1354068811436037
Caciagli,
Mario (2011), Subculture politiche territoriali o geografia elettorale?, SocietàMutamentoPolitica,
Vol.2, No.3, pp.95-104.
Cain, Bruce et al.
(1987), The Personal Vote. Constituency Service and Electoral
Independence. Cambridge: Harward University Press.
Calise,
Mauro (2000), Il partito personale. Roma-Bari: Laterza.
Casal Bértoa, Fernando (2014), Party systems and
cleavage structures revisited: a sociological explanation of party system
institutionalization in East Central Europe, Party Politics, Vol.20,
No.1, pp.16-36.
De Luca (2001), Il ritorno dei “campioni
delle preferenze” nelle elezioni regionali, Polis, No.2, pp.227-248.
De Luca (2011), Alcuni effetti del voto
“personale” negli esiti e nella partecipazione elettorale, presentato al XXV
Convegno SISP, Palermo, Italia, 8-10 Settembre.
Emanuele, Vincenzo e Chiaramonte, Alessandro
(2020), Going out of the ordinary. The de-institutionalization of the Italian
party system in comparative perspective, Contemporary Italian Politics,
Vol.12, No.1, pp.4-22.
Emanuele, Vincenzo e
Marino, Bruno (2016), Follow the Candidates, Not the Parties? Personal Vote in
a Regional De-institutionalized Party System, Regional & Federal Studies,
Vol.26, No.4, pp.531-554.
Hooghe, Liesbet e Marks, Gary (2018), Cleavage
theory meets Europe’s crises: Lipset, Rokkan, and the transnational cleavage, Journal
of European Public Policy, Vol.25, No.1, pp.109-135.
Karvonen, Lauri
(2010), The personalisation of politics. A study of parliamentary
democracies. Colchester: ECPR Press.
Kriesi, Hanspeter (2006), Globalization and the
transformation of the national political space: Six European countries
compared, European Journal of Political Research, Vol.45, No.6,
pp.921-956.
Mainwaring, Scott e Scully, Timothy R. (1995), Building Democratic Institutions: Party Systems in Latin America. Stanford: Stanford University Press.
Napoli,
Daniela (2005), Dove le preferenze contano – Il caso della Calabria, Le
Istituzioni del Federalismo, Vol.6, pp.1142-1182.
Parisi, Arturo e Pasquino, Gianfranco (1977),
Continuità e mutamento elettorale in Italia. Le elezioni del 20 giugno 1976
e il sistema politico italiano. Bologna: Il Mulino.
Passarelli, Gianluca (2017), Determinants of
Preferential Voting in Italy: General Lessons from a Crucial Case, Representation,
Vol.53, No.2, pp.167-183.
Scaramozzino, Pasquale (1990), Il Voto di
Preferenza Nelle Elezioni Regionali, Il Politico, Vol.55, No.2,
pp.293-311.
Valbruzzi,
Marco (2019), Allerta rossa per l’onda verde. Politica, economia e società in
Emilia-Romagna alla vigilia del voto regionale, Misure/Materiali di ricerca
dell’Istituto Cattaneo, Vol.42.
[1] L’elezione dei candidati al
consiglio regionale avviene, infatti, su base provinciale.