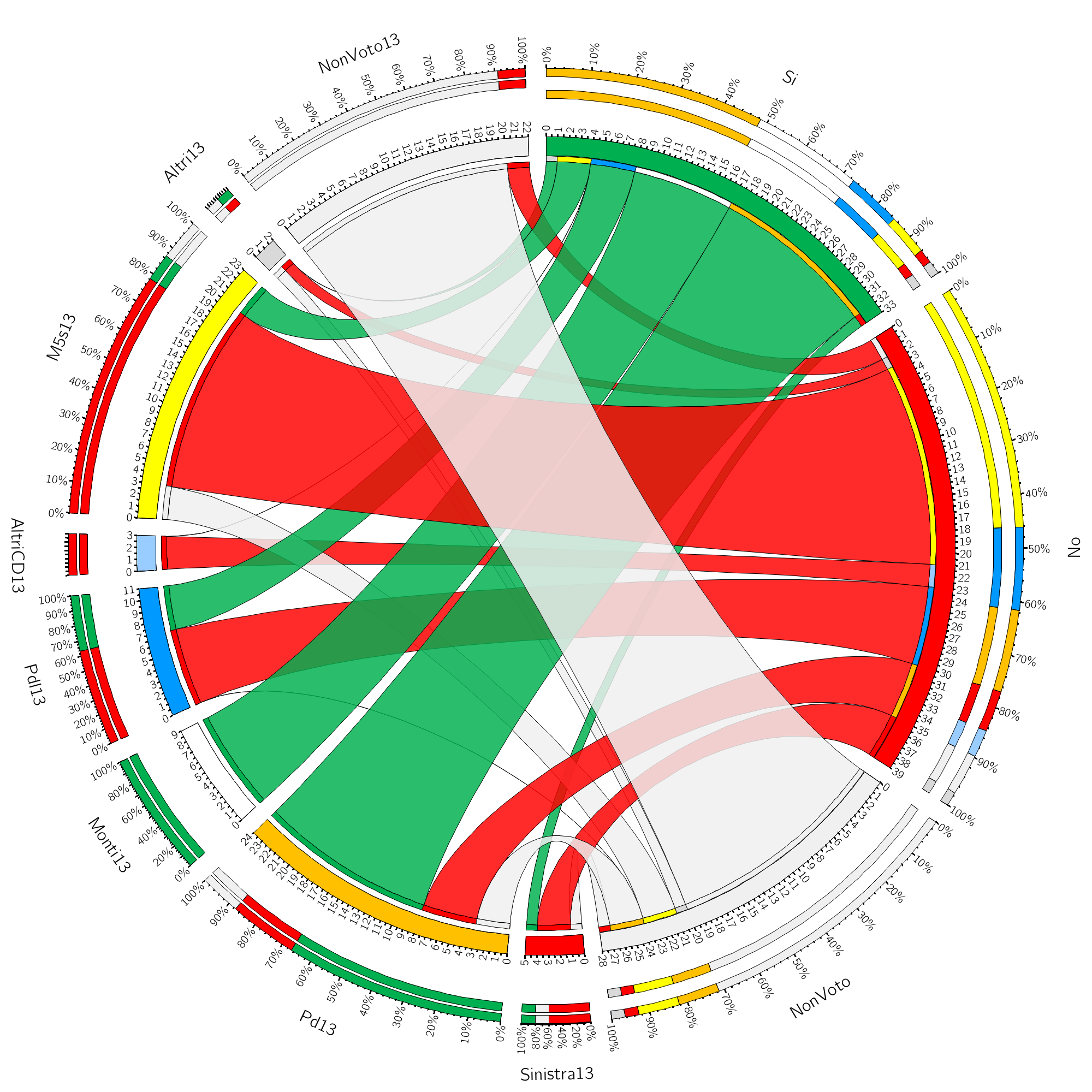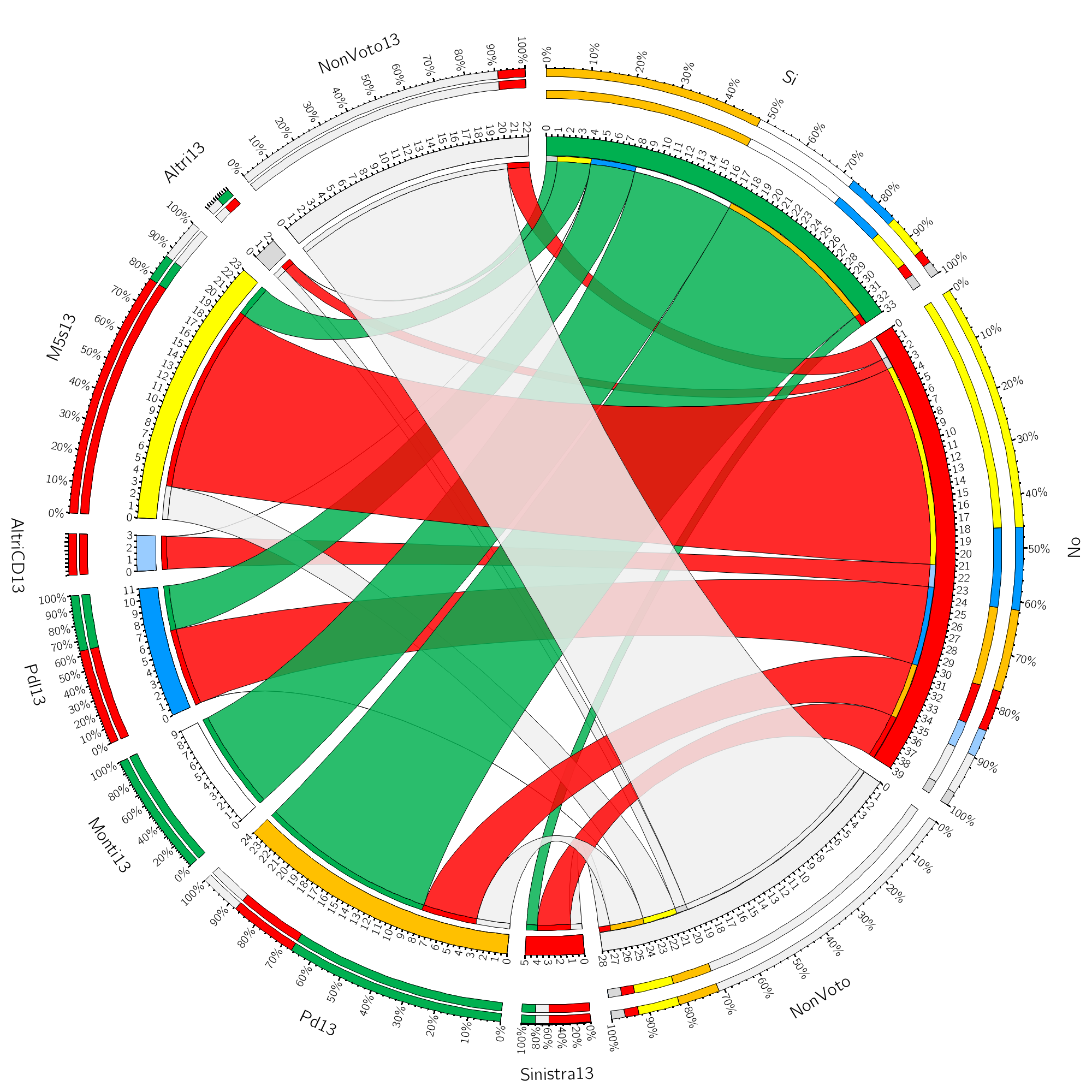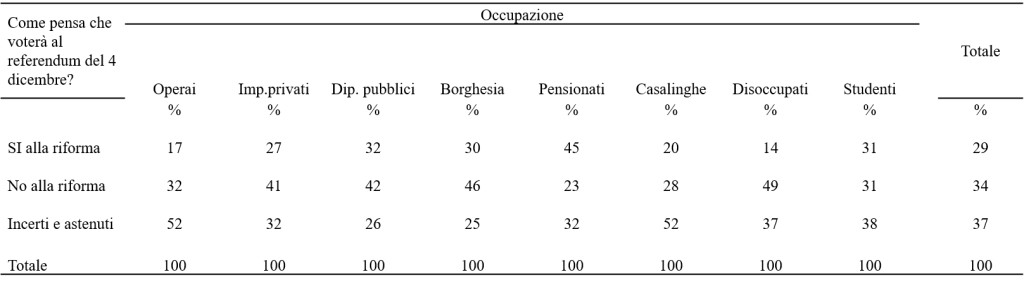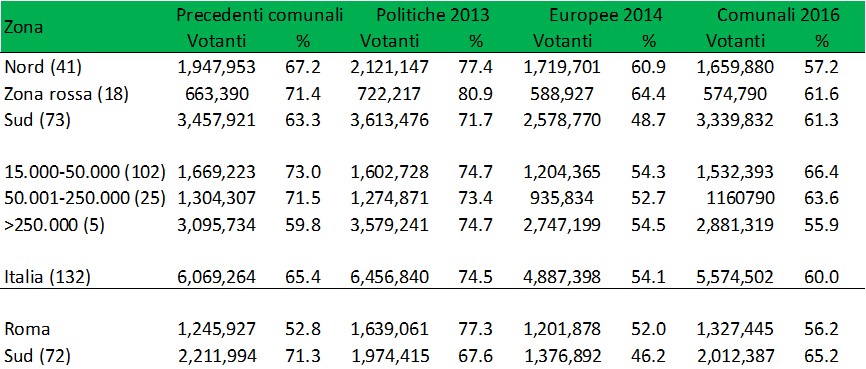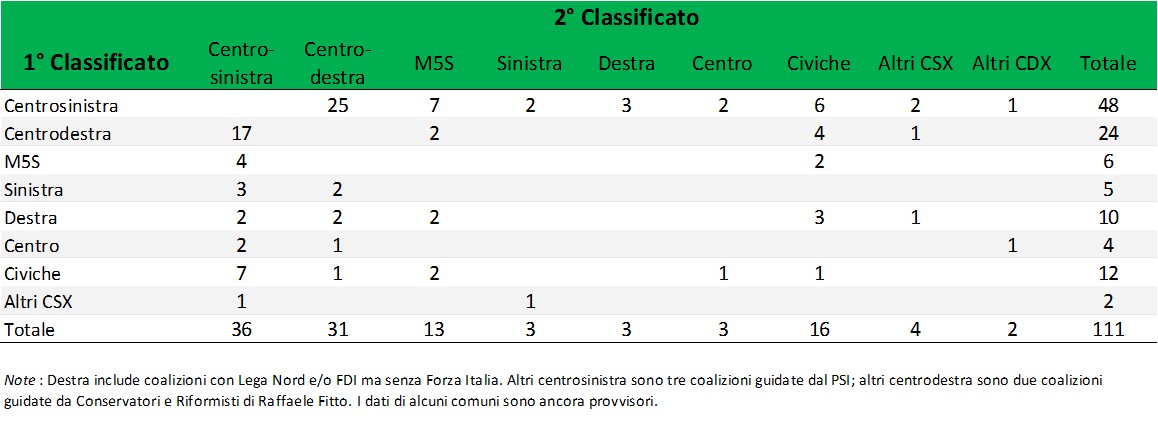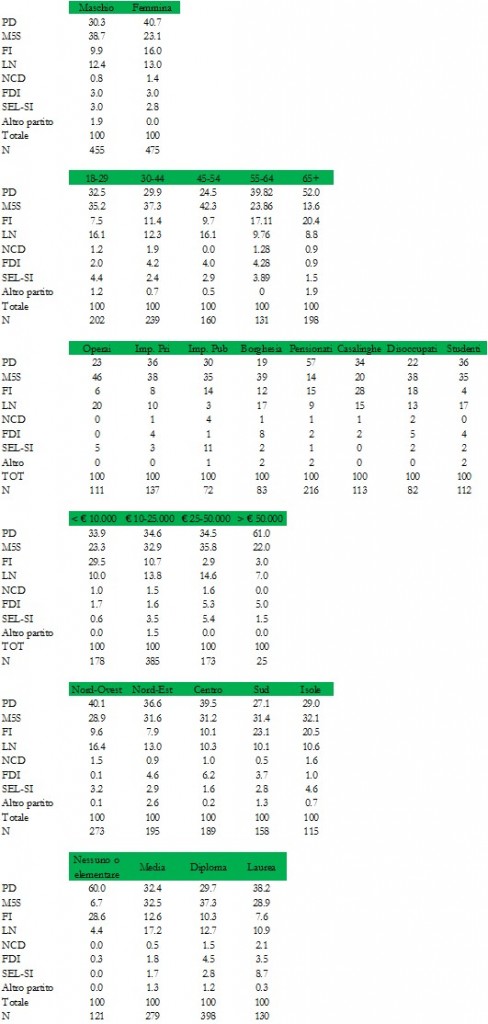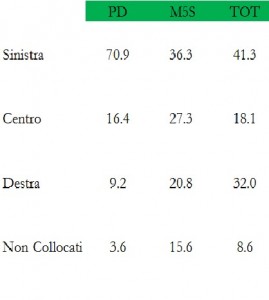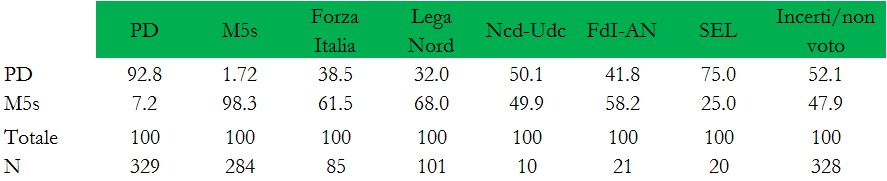di Vincenzo Emanuele, Bruno Marino e Nicola Martocchia Diodati
Il prossimo 5 giugno si svolgerà la più importante tornata elettorale da qui alle prossime elezioni politiche. Saranno coinvolti circa 15 milioni di italiani per un voto amministrativo che coinvolgerà 1342 comuni di cui 149 superiori[1] e 25 capoluoghi di provincia. A questi si aggiungono Bolzano e gli altri 19 comuni del Trentino-Alto Adige che hanno votato l’8 maggio scorso e Ayas (Valle D’Aosta) che ha votato lo scorso 15 maggio.
Si tratterà di un test importante, ancorché forse non ancora decisivo, per Renzi e il Partito Democratico, chiamati ad un risultato positivo per proiettarsi verso la sfida cruciale del referendum costituzionale di ottobre e delle successive elezioni politiche. Finita la ‘luna di miele’ del 2014 (con il roboante 40,8% delle elezioni europee del 2014), Matteo Renzi ha superato con relativo successo lo scoglio delle regionali del 2015, vincendo in 5 regioni su 7 e, nonostante il forte arretramento in termini di fiducia (sia personale sia del governo) registrato da tutti i sondaggi, si presenta a queste amministrative come il vero dominus della politica italiana. Il rovescio della medaglia, naturalmente, riguarda il fatto che Renzi sia allo stesso momento anche il bersaglio al quale puntano le opposizioni: la vittoria alle amministrative, o almeno in qualche città chiave, da parte del M5S o delle destre (sono quasi sempre almeno due), ne legittimerebbe la richiesta di elezioni anticipate, mettendo ulteriore pressione su un governo da sempre fragile sia per i numeri di cui dispone che per il ‘vizio’ di essere nato in parlamento e non nelle urne. Il Pd, primo secondo tutti i sondaggi e incumbent nella stragrande maggioranza delle città al voto, si trova nella scomoda posizione di chi ha tutto da perdere e fronteggia una campagna elettorale resa ancor più difficile dalle divisioni interne tra renziani e minoranza, dai quasi giornalieri scandali giudiziari che coinvolgono ogni giorno suoi esponenti sul territorio e, infine, dai postumi dello scandalo di Mafia Capitale a Roma, città che rappresenta il vero ago della bilancia di questa tornata elettorale.
D’altro canto, anche per il Movimento 5 Stelle si tratta di un passaggio decisivo. Con la morte di Casaleggio, il progressivo allontanamento di Beppe Grillo dalla politica e lo sviluppo di una classe dirigente interna che sta acquisendo autonomia in Parlamento e visibilità sui media (Di Maio è ad oggi secondo solo a Renzi per quanto concerne la fiducia nei leader), il Movimento è in piena fase di trasformazione e queste amministrative gli offrono l’irripetibile occasione di compiere il salto decisivo da partito anti-establishment di protesta a mainstream opposition con potenziale di governo. Dopo le prime, piuttosto complesse, esperienze di governo in alcune città (Quarto, Livorno, Ragusa, per non parlare dei recenti problemi a Parma), vincere a Roma potrebbe rappresentare un grande trampolino in vista delle prossime politiche e dare al Movimento quella credibilità che ancora non riesce ad ottenere agli occhi della classe dirigente italiana e della grande stampa.
Infine, il centrodestra. Unito, come a Milano, rappresenta un polo assolutamente competitivo per la vittoria. Diviso, come a Roma, rischia seriamente di rimanere escluso dai ballottaggi. Ma la vera partita il centrodestra non la gioca contro il Pd o il M5S. Non conterà tanto il numero di città vinte (oltretutto negli ultimi cinque anni le amministrative sono sempre state una Caporetto per il centrodestra). La vera nodo delle amministrative per il centrodestra è tutto interno, nella conta fra la nuova, rampante, destra di Salvini e Meloni e il tradizionale, decadente, blocco berlusconiano. Se l’Italicum dovesse rimanere la legge elettorale con cui si voterà alle prossime elezioni politiche, non ci sarà spazio per due alternative di destra. Queste comunali potrebbero dirci quale delle due dovrà farsi da parte.
La situazione di partenza
Prima di osservare le caratteristiche dell’offerta elettorale attuale, diamo un’occhiata alla situazione di partenza nei 25 comuni capoluogo al voto, confrontandola con il precedente turno amministrativo del 2011[2]. Alle elezioni amministrative del 2011, in 21 comuni la vittoria era andata al centrosinistra, mentre in 4 comuni il candidato sindaco di centrodestra aveva ottenuto più voti (a Napoli, invece, aveva vinto De Magistris sostenuto da una coalizione di Idv e Federazione della sinistra)[3]. Eppure, dopo cinque anni osserviamo un significativo cambiamento di queste percentuali: il primo dato, per certi versi sorprendente, riguarda il fatto che 6 comuni, ovvero quasi il 25%, andranno al voto sotto commissariamento prefettizio. All’interno di questi comuni vi è il caso più eclatante, quello di Roma, che ha visto le dimissioni di 26 consiglieri, evento che ha portato alla caduta dell’amministrazione guidata da Ignazio Marino. Ciononostante, un buon numero di comuni arriva all’appuntamento del prossimo giugno con la stessa amministrazione eletta cinque anni fa: 16 comuni guidati dal centrosinistra, 2 guidati dal centrodestra e uno sostenuto dalla sinistra radicale (De Magistris). Questo dato enfatizza il ruolo del Pd come vero incumbent[4] della competizione.
Di questi 19 comuni, 9 vedono la ricandidatura del sindaco uscente. I nomi più eclatanti sono Virginio Merola a Bologna, Luigi de Magistris a Napoli, Piero Fassino a Torino e Massimo Zedda a Cagliari. Passando ad un’analisi più generale dell’offerta politica nei 25 capoluoghi, è interessante confrontare i dati di liste, candidati e coalizioni con la precedente tornata del 2011. Il 2011 aveva segnato, pur in presenza di una logica di competizione fondamentalmente bipolare, un netto aumento della frammentazione rispetto al passato, sia in termini di candidati (da 5,5 di media a 8) che di liste (da 5 a 9,3) (Emanuele e Paparo 2011) [5]. Visto l’avvenuto passaggio dal bipolarismo che ha caratterizzato la Seconda Repubblica alla nuova fase tripolare emersa dopo le politiche 2013 sia a livello nazionale (Chiaramonte e Emanuele 2014) che regionale (Tronconi 2015), ci si sarebbe potuti attendere un radicale cambiamento della configurazione dell’offerta nel 2016 rispetto al 2011, con un incremento della frammentazione in termini di candidati sindaco e una diminuzione delle liste a sostegno di ciascuno di loro. In altri termini, si potrebbe immaginare il passaggio, anche a li vello locale, da una competizione fra coalizioni ad una fra singoli partiti. Eppure, due disincentivi sistemici impediscono tale trasformazione: il sistema elettorale comunale, che spinge i partiti a coalizzarsi per raggiungere il premio di maggioranza, e la presenza del voto di preferenza, che incentiva la moltiplicazione delle liste e la corsa dei partiti ad accaparrarsi quante più alleanze possibili con i ras locali del voto (Emanuele e Marino 2015). È possibile che questi disincentivi influenzino la situazione di partenza, che risulta per certi versi essere molto simile al 2011, sia in termini di candidati sindaco (8,5 di media nelle 25 città, leggermente più che nel 2011), sia di liste in competizione (22,2 di media contro le 21,6 del 2011).
Quello che cambia, ma non troppo, è il dato del numero di liste a sostegno di candidati fuori dai due ‘blocchi’ principali (ovvero quelli comprendenti il Pd e FI[6]): oggi sono 10,4 ma nel 2011 erano 9,3. Per quanto concerne il numero medio di liste all’interno delle due principali coalizioni, vi sono in media 5.8 liste per le coalizioni a guida Pd e 6 per quelle a guida FI, per un totale di 11,8. Il dato di FI è in leggera flessione rispetto al 2011 (le liste in coalizione a guida PdL erano in media 6,4) ma è curioso il fatto che tale partito, nonostante il disfacimento della coalizione di centrodestra in molte città, riesca ad aggregare ancora diverse liste a sostegno dei candidati che sostiene. Un’analisi più approfondita delle coalizioni in cui è presente Forza Italia rivela il grande ruolo giocato dalle liste ‘non nazionali’, cioè civiche e locali: su un totale di 127 liste incluse nelle coalizioni in cui è presente il partito di Berlusconi, oltre il 60%, ben 77, sono liste non riferibili ad etichette nazionali. Un altro dato interessante è, naturalmente, la grande variabilità a livello di liste e candidati tra le diverse città: si va dai 17 candidati sindaco di Torino ai 5 di Cosenza, Olbia e Ravenna, dalle 41 liste di Napoli, alle 14 di Savona e Ravenna. In generale, notiamo una maggiore frammentazione a livello di lista al Sud con una media di 26,1 liste contro le 18.1 del Centro-Nord. Al contrario, la competizione per il sindaco risulta più variegata al Centro-Nord rispetto al Sud (in media si presentano 8.9 candidati al Centro-Nord contro i 8,2 del Sud). In altre parole, se al Centro-Nord la competizione è soprattutto per la carica di sindaco, al Sud invece la vera partita si gioca per la conquista di un posto all’interno del consiglio comunale.
Complessivamente, ciascun candidato sindaco è sostenuto, in media, da 2,6 liste. In nessuna delle 25 città Pd o FI si presentano da soli, ma sempre con almeno un’altra lista a proprio sostegno, a differenza del M5S che corre da solo in tutti i comuni (ma è assente a Latina). Nonostante l’attenzione dei media si sia concentrata sulla frammentazione del centrodestra a Roma (vedi sotto), i dati ci confermano che la crisi di questa parte dello schieramento politico non è limitata alla Capitale. Al contrario, in ben 8 comuni capoluogo su 25 Forza Italia e la Lega Nord (o Noi con Salvini) non presentano un candidato unico alla guida della città. Anche la vecchia alleanza PD-SEL di bersaniana memoria risulta frantumata: è presente solo in 8 comuni su 25.
L’offerta politica nelle principali città
TUTTE LE TABELLE CON L’OFFERTA POLITICA NEI CAPOLUOGHI QUI (aggiornate al 4 giugno 2016)
Questi dati ci restituiscono una fotografia generale dell’offerta politica nei capoluoghi chiamati al voto. È utile ora analizzare nel dettaglio la situazione di partenza nelle cinque città principali: Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli.
TORINO – Il sindaco uscente Piero Fassino cerca la riconferma dopo cinque anni in Comune, sostenuto dal PD e da altre tre liste. A sinistra sarà sfidato da Giorgio Airaudo, deputato di Sinistra Ecologia e Libertà. Nonostante nel (centro) sinistra non si presenti un candidato unitario, spostandosi verso il centrodestra la situazione è ancora più frammentata: mentre l’UdC, in una coalizione con altre quattro liste, sostiene Roberto Rosso, ex forzista, il vecchio partito di Rosso, FI, supporta invece, assieme ad altre due liste civiche, la candidatura di Osvaldo Napoli, ex deputato di Forza Italia. Lega Nord e FdI, replicando uno schema di coalizione già presente in altre città, candidano, assieme ad una lista civica, Alberto Morano, notaio torinese. Infine il Movimento Cinque Stelle sostiene l’imprenditrice Chiara Appendino.
MILANO – Rispetto al capoluogo sabaudo, a Milano la competizione sembra seguire ancora il vecchio schema bipolare fra le due coalizioni principali: la conquista di Palazzo Marino si gioca fra il centrosinistra, che candida l’ex commissario all’Expo Giuseppe Sala, sostenuto dal Pd e da altre tre liste, e Stefano Parisi che corre per lo schieramento di centrodestra, che include FI, Lega Nord, Fratelli d’Italia e Milano Popolare (lista che include importanti politici del Nuovo Centro Destra come Maurizio Lupi). Il Movimento Cinque Stelle, mai realmente in corsa per la vittoria, propone la candidatura a sindaco di Gianluca Corrado, avvocato che ha sostituito, non senza polemiche, Patrizia Bedori, uscita vincente dalle ‘comunarie’ grilline in città.
BOLOGNA – Il sindaco uscente di centrosinistra, Virginio Merola, si ripresenta, sostenuto dal Pd e da altre quattro liste. FI, Lega Nord e FdI supportano invece la leghista Lucia Borgonzoni, che può anche contare sull’appoggio di due liste civiche. L’ex leghista Manes Bernardini corre per una lista civica, mentre il M5S sostiene Massimo Bugani, già candidato sindaco con lo stesso partito nel 2011 e consigliere comunale uscente.
ROMA – La campagna elettorale e la presentazione delle liste nella capitale hanno occupato un buon numero di prime pagine dei principali quotidiani italiani. Non è difficile capire perché: vincere o perdere a Roma ha un valore simbolico non indifferente. Mafia Capitale e le dimissioni di Ignazio Marino hanno scompaginato il fronte politico capitolino, che vede un gran numero di candidati sindaco. Il PD, assieme ad altre sei liste, sostiene Roberto Giachetti, ex radicale, parlamentare del Pd e vice-presidente della Camera dei Deputati. Nel fronte opposto, due sono i principali candidati: Alfio Marchini, già candidatosi alle ultime comunali, sostenuto da FI e da altre sei liste, e Giorgia Meloni, leader di FdI, che è sostenuta da Noi con Salvini e da altre tre liste. L’avvocato Virginia Raggi, vera favorita della competizione secondo tutti i sondaggi, corre sotto le bandiere del M5S. Come sostenuto da Roberto D’Alimonte[1], sembra che il centrodestra stia utilizzando il primo turno in città come una specie di ‘elezione primaria’ per la leadership. Riteniamo che tale argomentazione rimanga valida anche dopo il ritiro di Guido Bertolaso in seguito alla decisione di Silvio Berlusconi di appoggiare Alfio Marchini. In questo senso, i risultati delle elezioni amministrative a Roma avranno certamente un eco che supererà facilmente i confini della città.
NAPOLI – Anche a Napoli la costruzione dell’offerta politica è stata travagliata. In questo caso è il centrosinistra ad aver affrontato i problemi più gravi: basti ricordare la contestata vittoria alle primarie di centrosinistra di Valeria Valente contro Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli ed ex presidente della Campania. Valente è sostenuta da ben 11 liste. Sono invece 10 (erano quattro nel 2011), quasi tutte civiche, le liste a sostegno del sindaco uscente, l’ex magistrato Luigi de Magistris. FdI candida Marcello Taglialatela, sostenuto anche da un’altra lista. Infine, lo sconfitto al ballottaggio di cinque anni fa, Gianni Lettieri, guida una coalizione composta da Fi e da altre nove liste. Il M5S sostiene Matteo Brambilla, vincitore a sorpresa delle elezioni primarie grilline.
Bibliografia
Cataldi, M., Emanuele, V. e Paparo, A. (2012), ‘Elettori in movimento nelle Comunali 2011 a Milano, Torino e Napoli’, Quaderni dell’Osservatorio Elettorale, 67(1), pp. 5-43.
Catellani, P. e Alberici, A. I. (2012), ‘Does the Candidate Matter? Comparing the Voting Choice of Early and Late Deciders’, Political Psychology, 33(5), pp. 619-634.
Chiaramonte, A. e Emanuele, V. (2014), ‘Bipolarismo Addio? Il Sistema Partitico tra Cambiamento e De-Istituzionalizzazione’, in A. Chiaramonte e L. De Sio (a cura di), Terremoto elettorale. Le elezioni politiche 2013, Bologna, Il Mulino, pp. 233-262.
D’Alimonte, R. (2015), ‘A Roma il primo turno di trasforma in primarie’, /cise/2016/03/20/a-roma-il-primo-turno-si-trasforma-in-primarie/.
Emanuele, V. e Paparo, A. (2011), ‘Comunali 2011: offerta politica nei comuni capoluogo di provincia’, /cise/2011/05/10/comunali-2011-offerta-politica-nei-comuni-capoluogo-di-provincia/.
Emanuele. V. e Maggini, N. (2015), ‘Il Partito della Nazione? Esiste, e si chiama Movimento 5 Stelle’, /cise/2015/12/07/il-partito-della-nazione-esiste-e-si-chiama-movimento-5-stelle/.
Emanuele, V. e Marino, B. (2015), ‘From a party system to a ‘candidate system’? ‘Lords of Preferences’ and electoral support in Calabria, paper presentato al 29° convegno della Società Italiana di Scienza Politica (SISP), Arcavacata di Rende (Cosenza), 10-12 Settembre 2015.
Gelman, A. e King, G. (1990), ‘Estimating Incumbency Advantage Without Bias’, American Journal of Political Science, 34(4): pp. 1142-1164.
Tronconi, F. (2015), ‘Bye-Bye Bipolarism: The 2015 Regional Elections and the New Shape of Regional Party Systems in Italy’, South European Society and Politics, 20(4): pp. 553-571.
[1] Questo dato comprende 6 comuni siciliani che votano da superiori in virtù della legge regionale ma non hanno i 15.000 abitanti richiesti dalla legge nazionale (sono infatti compresi tra 10.000 e 14.999 abitanti). Inoltre 11 comuni dei rimanenti 143 non erano superiori nella precedente tornata amministrativa.
[2] Bolzano è inclusa nelle analisi di questo articolo per quanto concerne le considerazioni generali sull’offerta elettorale. Per ulteriori approfondimenti si veda l’articolo di Federico De Lucia /cise/2016/05/04/il-primo-test-delle-comunali-2016-lofferta-politica-a-bolzano/. Al contrario, Villacidro è esclusa dalle analisi in quanto, essendo inferiore ai 15.000 abitanti, presenta liste uniche per ciascun candidato. Si noti come a Giugno andranno alle urne Brindisi, Caserta, Isernia e Villacidro (che non elessero il sindaco nel 2011), mentre nel 2011 andarono alle urne Rovigo, Arezzo, Siena, Fermo, Barletta, Reggio Calabria, Ragusa, Iglesias (e questi comuni non eleggeranno il sindaco nel prossimo Giugno).
[3] Per un approfondimento sul risultato e i flussi elettorali alle comunali del 2011 a Napoli, si veda Cataldi, Emanuele e Paparo (2011).
[4] Sul cosidetto incumbency effect si veda Gelman and King (1990).
[5] /cise/2011/05/10/comunali-2011-offerta-politica-nei-comuni-capoluogo-di-provincia/.
[6] Tale criterio è stato utilizzato per facilitare il confronto con il 2011, quando la competizione era chiaramente bipolare e basata sul confronto fra candidati del centrosinistra capeggiato dal Pd e del centrodestra capeggiato dal PdL.
[7] /cise/2016/03/20/a-roma-il-primo-turno-si-trasforma-in-primarie/.
[8] Peraltro, riguardo tale ipotesi, il sondaggio CISE dello scorso Novembre ha mostrato come, in un eventuale ballottaggio tra M5S e PD alle elezioni politiche, grazie alle seconde preferenze degli elettori di centrodestra, il M5S potrebbe battere il Pd (Emanuele e Maggini 2015). /cise/2015/12/07/il-partito-della-nazione-esiste-e-si-chiama-movimento-5-stelle/.