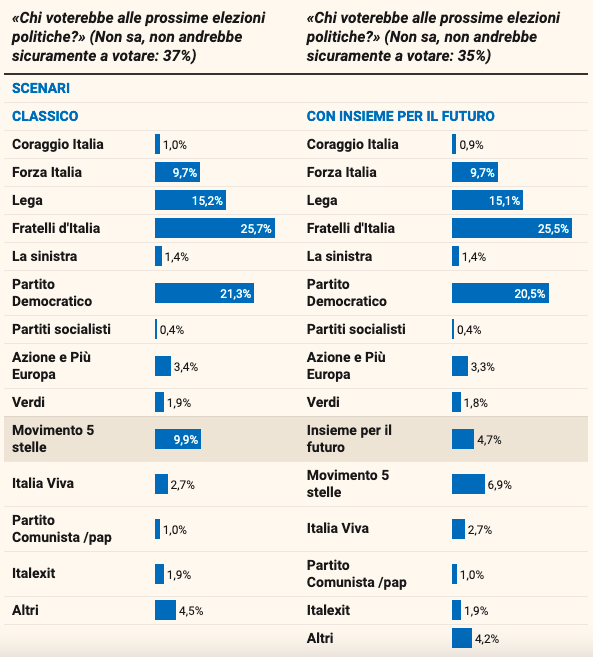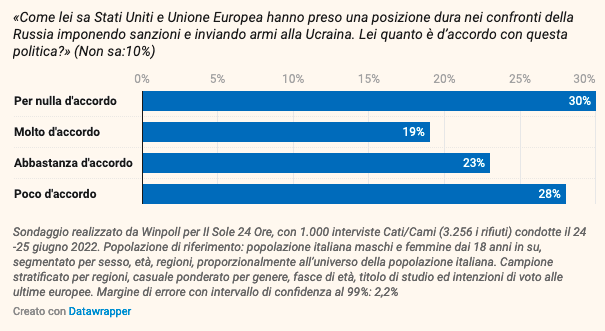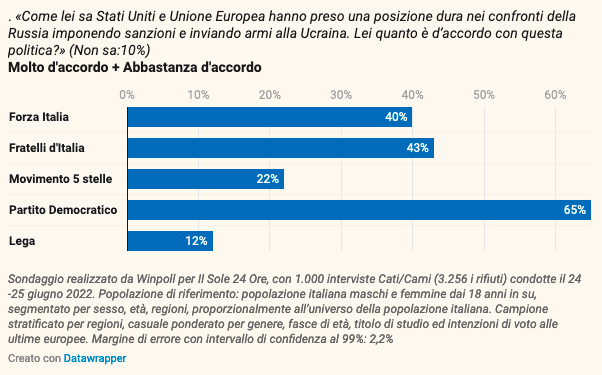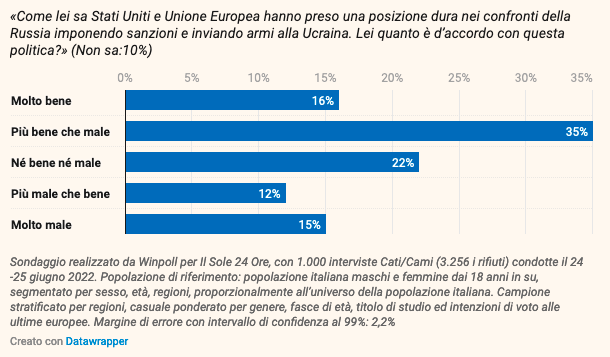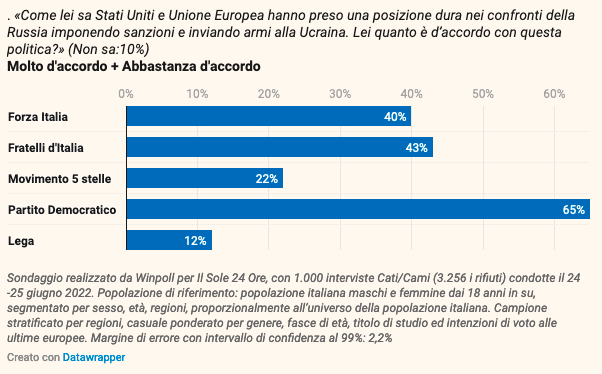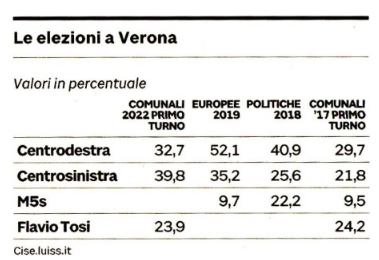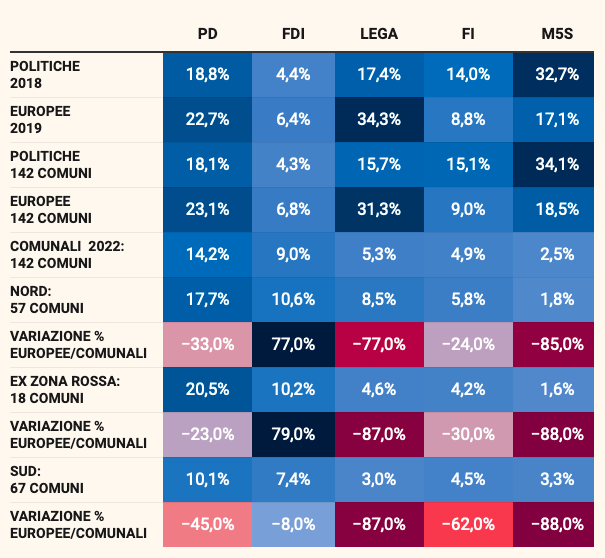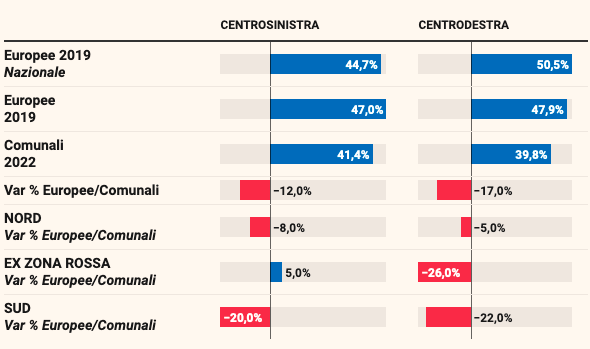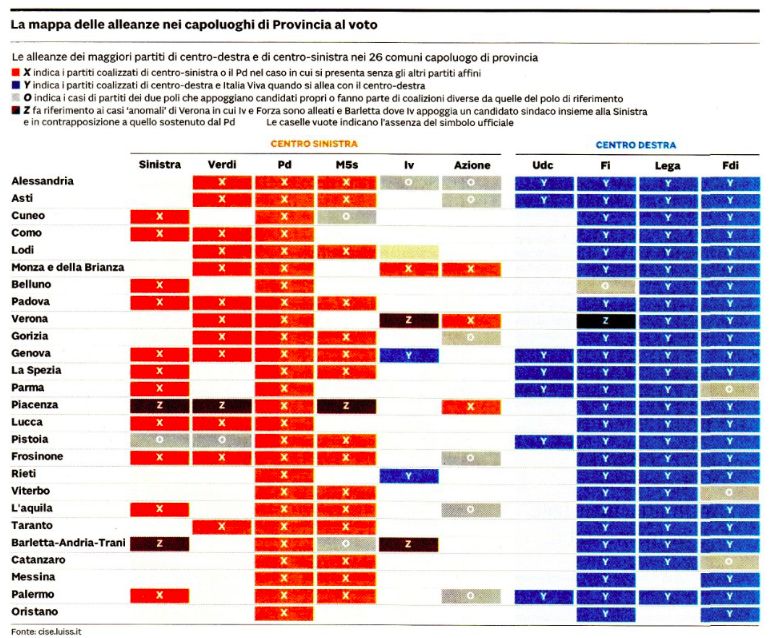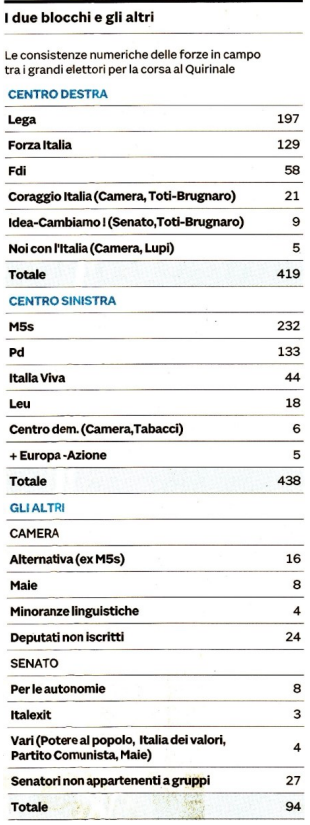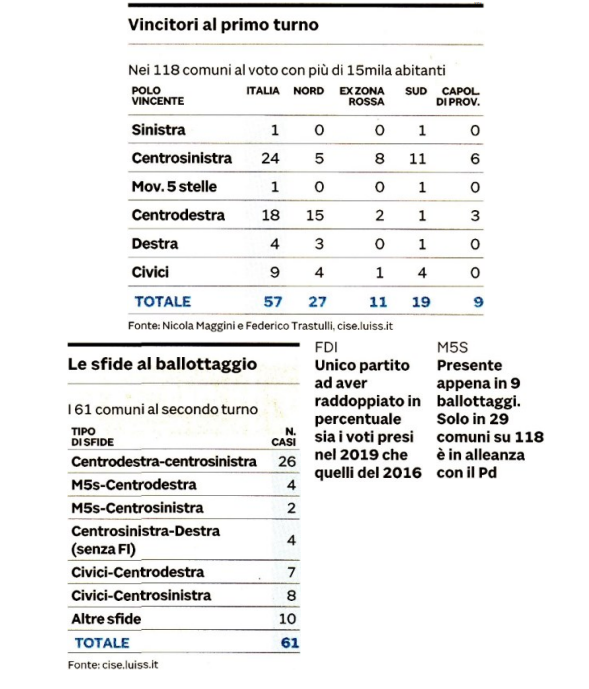Pubblicato su Il Sole 24 Ore il 9 luglio
I collegi uninominali danno fastidio a tutti. Con l’attuale sistema elettorale i partiti in coalizione sono spinti a scegliere 147 candidati comuni alla Camera e 74 al Senato. È così che in Italia sono stati da sempre utilizzati i collegi uninominali. Questo vuol dire che prima del voto Salvini e Meloni da una parte, così come Letta e Conte dall’altra, dovranno sedersi intorno a un tavolo e litigare sulla spartizione tra loro dei 221 collegi in cui verranno presentati i candidati comuni delle rispettive coalizioni. Visti i rapporti e visti i sondaggi, l’operazione è complicata e insidiosa. Dunque c’è un interesse condiviso ad eliminare i collegi e tornare ad un sistema che preveda solo liste di partito.
Premio di maggioranza
Ma il centro-destra non ci sta a tornare ad un sistema che sia solo proporzionale, come vorrebbero il M5s e una bella fetta del Pd. Con il Rosatellum il centro-destra ha concrete speranze di vincere le prossime elezioni e non è disposto a rinunciarci ovviamente. Per questo, rebus sic stantibus, la sola strada percorribile per trovare un accordo bipartisan è quella di sostituite i collegi con il premio di maggioranza. Il Pd lo ha finalmente capito dopo aver flirtato insieme al M5s con il ritorno al proporzionale. In effetti il premio di maggioranza è l’equivalente funzionale del collegio. Sia l’uno che l’altro spingono i partiti ad allearsi prima del voto. Insieme alla sovra-rappresentazione del vincente questo è uno degli effetti maggioritari del sistema proporzionale con premio.
Il ritorno al premio non sarebbe una sorpresa. Torneremmo alla Calderoli, il famigerato “porcellum” in vigore tra il 2006 e il 2013. In fondo Il proporzionale con premio di maggioranza è uno degli ingredienti del modello italiano di governo introdotto sia nei comuni che nelle regioni. Nel 2005 fu introdotto anche a livello nazionale e anche in quel caso aveva sostituito i collegi uninominali della Mattarella. Adesso verrebbe riproposto in una versione costituzionalizzata. La sentenza della Consulta del 2013 sul porcellum ha fissato un paletto non aggirabile: un sistema proporzionale a premio deve contenere una soglia per farlo scattare. La Corte non ha fissato il suo livello. Ha solo detto che ci vuole. Non è più possibile che una coalizione con il 29% dei voti (il centro-sinistra di Bersani nel 2013) possa ottenere il 54% dei seggi alla Camera.
Le trattative Pd-Lega
Il
negoziato tra Pd e Lega verterà dunque soprattutto sul livello della
soglia per far scattare il premio. Più alta è la soglia, più difficile
che scatti il premio. Se il premio non scatta tutti i seggi verrebbero
distribuiti proporzionalmente. Va da sé che i proporzionalisti nei due
campi vorranno una soglia alta in modo da massimizzare la probabilità di
una distribuzione proporzionale di tutti i seggi. I fautori del
maggioritario la vorranno più bassa. Poi ci sono i terzo polisti. Anche
loro puntano ad una soglia alta in modo da poter giocare il loro
pacchetto di seggi dopo il voto se nessuno vincesse il premio.
Questa non è la sola soglia rilevante da decidere. Indipendentemente dal premio, è importante limitare la frammentazione fissando altre due soglie: una per impedire a partiti nani di prendere seggi , una altra per impedire la formazione di liste del tipo Forza Roma o Forza Milan create al solo scopo di raccattare voti per ottenere il premio. Queste soglie sono già previste nel Rosatellum. Se una lista non ottiene almeno il 3% dei voti non prende seggi e i suoi voti finiscono ai partiti alleati che stanno sopra la soglia. Inoltre, se non ottiene almeno l’1%, i suoi voti finiscono nel cestino. (https://primer.com.au/)
Premio di maggioranza al Senato
E
poi c’è la questione del premio di maggioranza al Senato. Adesso
vediamo cosa diranno quei giuristi che nel 2005 spinsero il presidente
Ciampi ad opporsi al premio nazionale al Senato invocando l’articolo 57
della Costituzione che secondo loro imponeva la regionalizzazione anche
del premio. È da lì che è nata la lotteria dei 17 premi regionali. Ma il
bello è che senza quella lotteria nelle elezioni del 2006 avremmo visto
Prodi vincente alla Camera e Berlusconi al Senato. Un bel pasticcio nel
nostro sistema di bicameralismo paritario. Questo per dire quanto sia
fragile e soggetto al caso il nostro sistema di formazione dei governi.
Ma quand’è che si rimetterà mano a una revisione ordinata e coerente del
nostro impianto istituzionale invece di continuare con questi rammendi
che non risolvono i problemi di fondo?