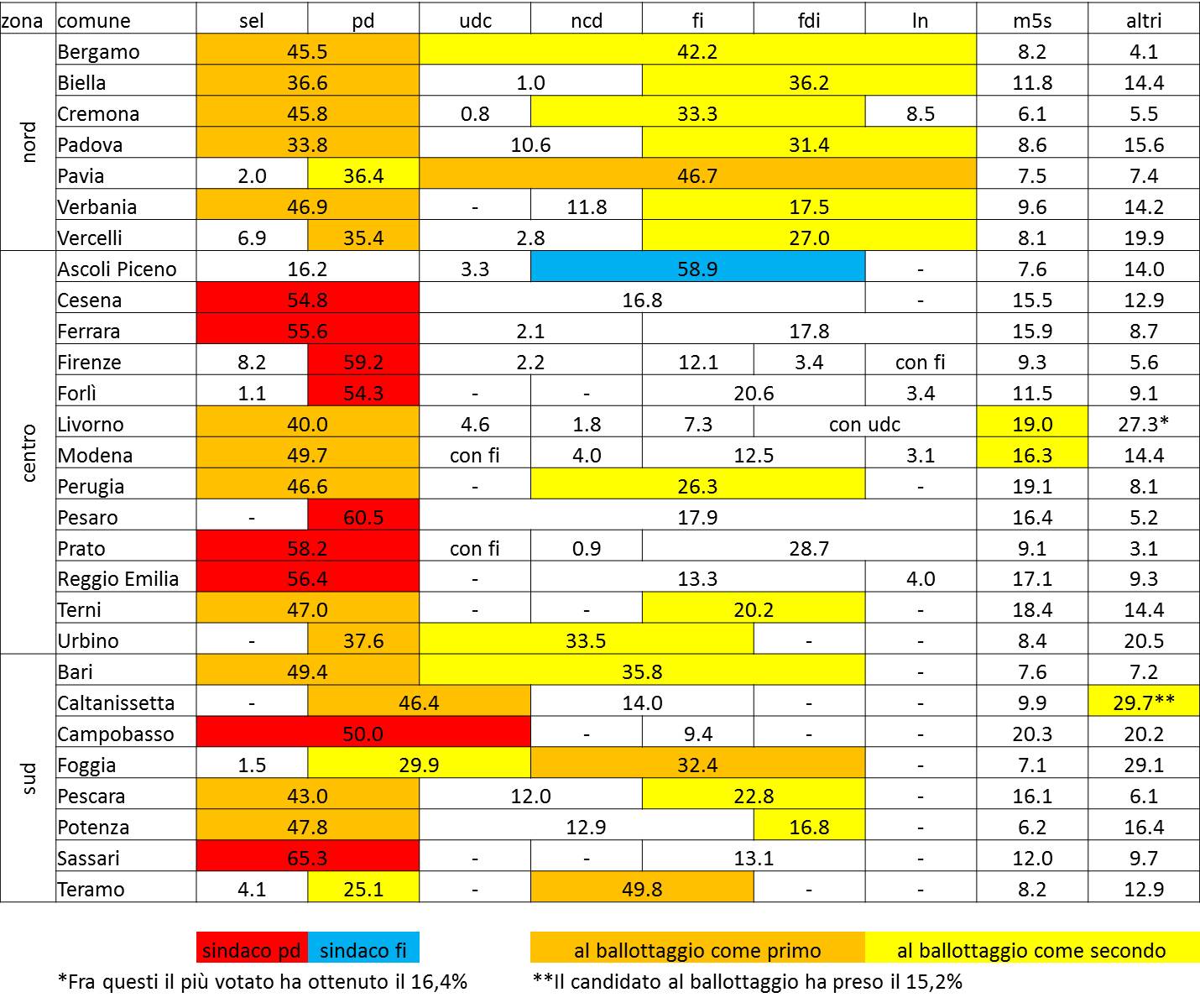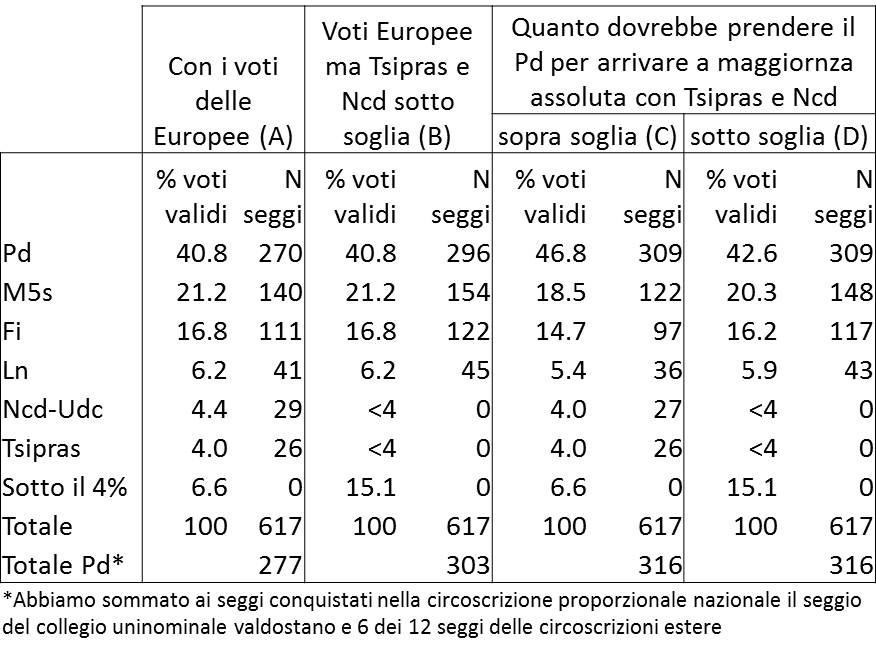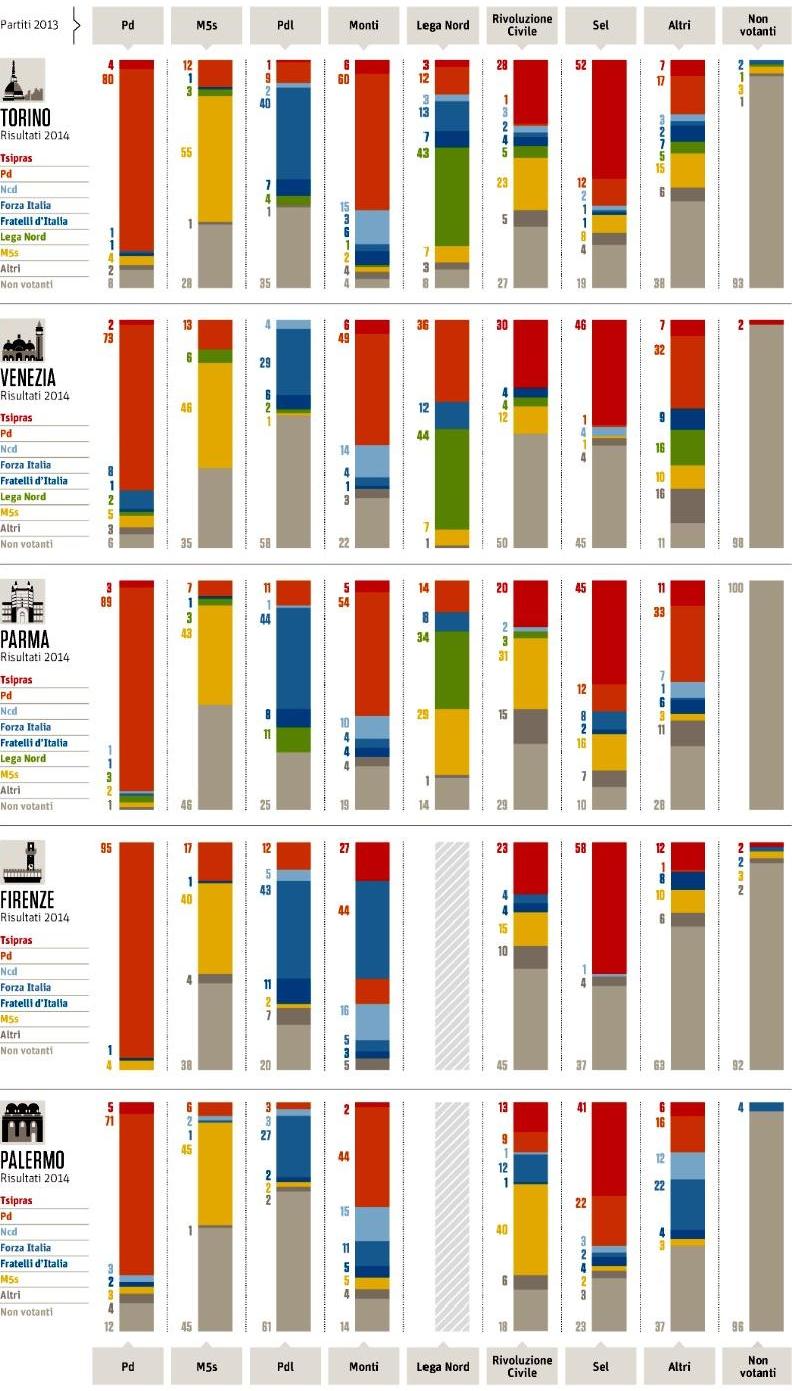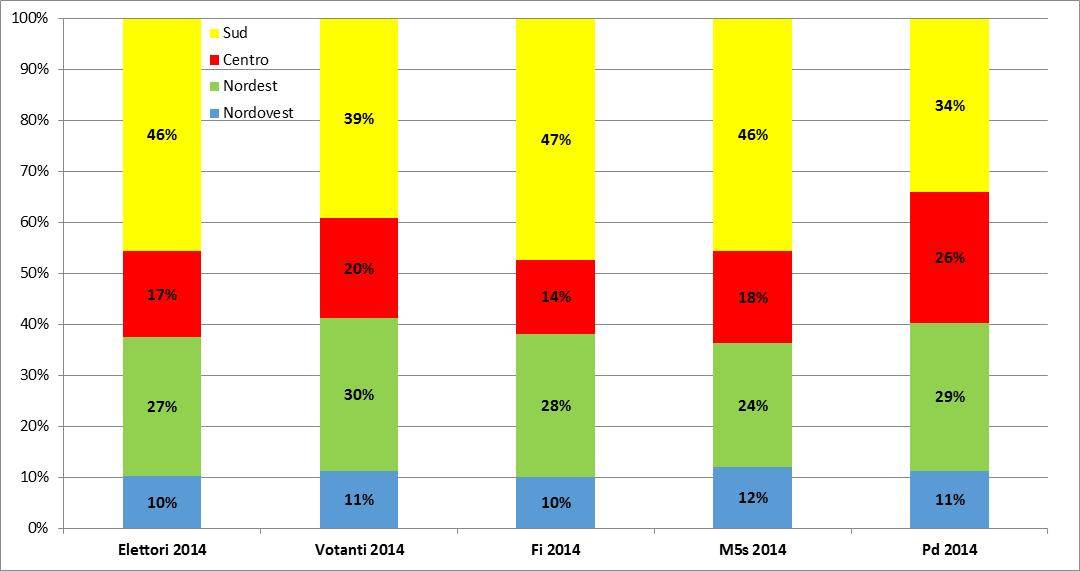di Roberto D’Alimonte
Pubblicato sul Sole 24 Ore del 7 dicembre 2014
Un quadro politico di grande fragilità in cui pessimismo e sfiducia sono le note dominanti. Questo è il dato saliente che emerge dall’ultimo sondaggio Cise-Sole24ore. In questo contesto Il Pd risulta ancora di gran lunga il primo partito del paese con il 39,3% delle intenzioni di voto, leggermente sotto il dato delle europee ma abbondantemente sopra quello delle politiche del 2013. Il fattore Renzi funziona ancora ma, come vedremo, mostra evidenti segni di sofferenza. Al secondo posto, nonostante tutto, si colloca il M5s con il 18,6%. Quella del movimento di Grillo sembra essere una discesa lenta, non un vero e proprio smottamento. Il suo punto di forza sono sempre i giovani tra i 18 e i 29 anni. In questo segmento dell’elettorato è ancora il partito più votato seguito dal Pd.
A ruota seguono gli altri. Forza Italia con il suo 15% si colloca al terzo posto sopravanzando di poco la Lega Nord. Anche questo sondaggio conferma che Berlusconi ha un suo nocciolo duro di consensi fatto di fedelissimi disposti a seguirlo sempre e comunque. Per Renzi è una buona notizia vista la disponibilità del Cavaliere a continuare sulla strada della collaborazione con il governo sulle riforme istituzionali.
Di questo sta approfittando la Lega Nord che ha trovato in Salvini un leader efficace. Il 14,3% è un dato notevole. Non si tratta ancora di voti ma solo di intenzioni. Ma abbiamo già visto nelle recenti elezioni regionali in Emilia-Romagna che lì le intenzioni si sono effettivamente trasformate in voti. Il declino di Berlusconi ha liberato milioni di elettori in cerca di un approdo stabile. Salvini cerca di approfittarne. E ci sta riuscendo. La sua strategia di radicalizzare il messaggio leghista in chiave di tematiche nazionali paga. Tre temi: Europa, immigrazione, diritti dei gay. Sono questi i temi di cui si sta impossessando il leader leghista. Un partito che non voglia diventare il partito della nazione può permettersi il lusso di radicalizzare la sua offerta politica sfruttando l’intensità delle opinioni su queste tematiche.
Il caso della domanda sui matrimoni gay è esemplare. L’opinione pubblica è nettamente polarizzata: il 36% è fortemente contrario mentre il 33% è assolutamente favorevole. Mettendo insieme pezzi di elettorato contrari ai diritti dei gay , all’Europa e alla immigrazione Salvini sta puntando a costruire un nuovo partito di destra nazionale. Lo aiutano le sue indubbie doti di comunicatore e lo spazio che gli altri da Berlusconi alla Meloni gli stanno lasciando. E così la Lega cresce e si allarga aldilà dei suoi confini tradizionali conquistando nuovi consensi ,soprattutto nella zona tra Bologna e Roma. Il suo punto di debolezza rimane il Sud. Ma Salvini sembra decisamente intenzionato a rimediare. Come riuscirà a fare di un partito che si chiama Lega Nord un partito nazionale è una bella sfida da seguire.
Dunque, Il Pd è il primo partito del paese, ma né il giudizio sul governo né quello su Renzi sono entusiastici. Il 40% degli intervistati approva l’operato dell’esecutivo ma tra questi solo il 3% è molto positivo, mentre tra i critici il 22% si esprime in modo fortemente negativo. Il giudizio sul premier è migliore di quello sul governo, ma neanche Renzi arriva alla sufficienza. In una scala da 1 a 10 solo il 46% gli dà un voto uguale o superiore a 6. Ma nessuno dei suoi avversari arriva alla sufficienza. Renzi resta quello che più gli si avvicina. Insomma, son tutti bocciati. Anche Salvini e Landini, per non parlare di Grillo e Berlusconi per cui i giudizi negativi sono intorno all’80%.
Sono dati che disegnano un quadro di profonda sfiducia nella classe politica. Sfiducia alimentata da un radicale pessimismo relativamente alla crisi economica. Oltre il 70% degli intervistati pensa che negli ultimi 12 mesi la situazione economica generale sia peggiorata. All’interno di questo quadro non tutti i partiti sono considerati alla stessa stregua. Nelle domande sulla credibilità, intesa come capacità di realizzare determinati obiettivi, il Pd ne esce meglio, ma non su tutto (si veda cise.luiss.it). E in ogni caso circa un terzo degli intervistati pensa che nessun partito sia credibile per ridurre i costi della politica, far ripartire l’economia o proteggere i cittadini dalla criminalità. Un quadro desolante.
L’Europa è la sezione del sondaggio che riserva le maggiori sorprese, relativamente parlando. Gli italiani non sono contenti dell’Unione. La stragrande maggioranza pensa che le decisioni prese a Bruxelles danneggino l’Italia (60%). Quasi il 70% è convinta che i sacrifici richiesti mettano in pericolo lo stato sociale. Si oppongono all’idea che le politiche dell’UE debbano privilegiare il rigore dei conti (80%). Anche il loro giudizio retrospettivo sui benefici della appartenenza del nostro paese all’Unione riflette una buona dose di scetticismo: solo il 51% ritiene che sia un fatto positivo. Eppure quando si chiede se l’Italia debba uscire dall’Euro il 50% dice di non essere affatto d’accordo e il 14% poco d’accordo. Fa il 64% di contrari all’uscita. E la stessa cosa si vede in risposta alla domanda sul futuro del processo di integrazione. Gli italiani si lamentano dell’Europa ma vogliono più Europa.
Rassegnazione o convinzione? Sia sull’Europa che sul governo e il suo leader si coglie negli atteggiamenti degli italiani una sostanziale ambiguità. E’ difficile capire se prevalga più l’uno o più l’altro di questi stati d’animo. Forse più il primo del secondo. La sensazione è che a Renzi e all’Europa non ci siano alternative. Ed è anche per questo che torniamo a sottolineare la fragilità del quadro politico. Fino a quando l’economia, che è la vera preoccupazione degli italiani, non avrà cambiato verso anche il 39% dei consensi al Pd resta un dato labile.
Ma di una cosa può gioire il premier. Sulla riforma elettorale gli italiani sono con lui. E’ veramente sorprendente che il 74% dichiari di essere d’accordo su una legge elettorale che debba garantire a chi vince le elezioni una maggioranza per governare, anche a costo di ridurre la rappresentanza degli altri partiti. In un paese dove una volta dominava la cultura della proporzionale scopriamo che la grande maggioranza è diventata disproporzionalista. Cambiare si può.