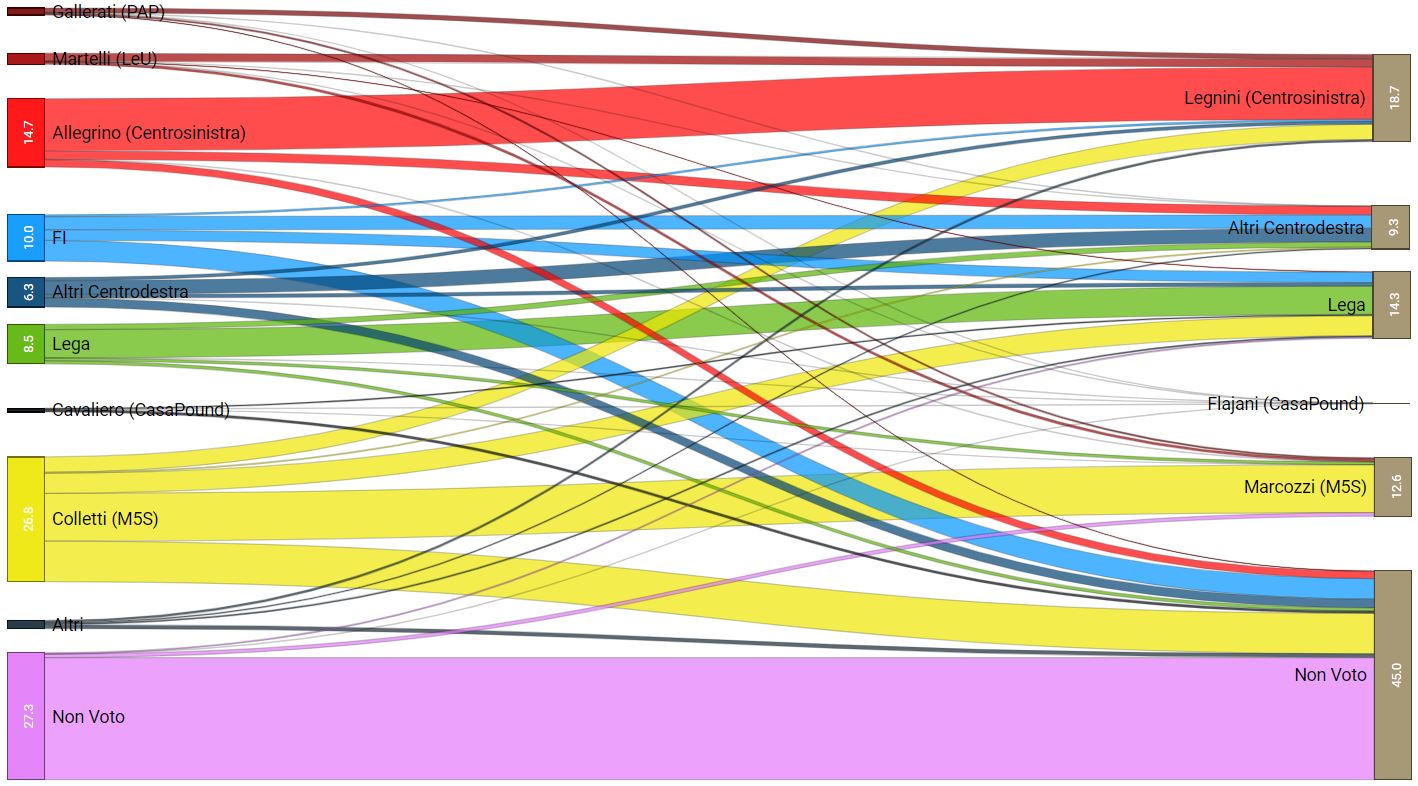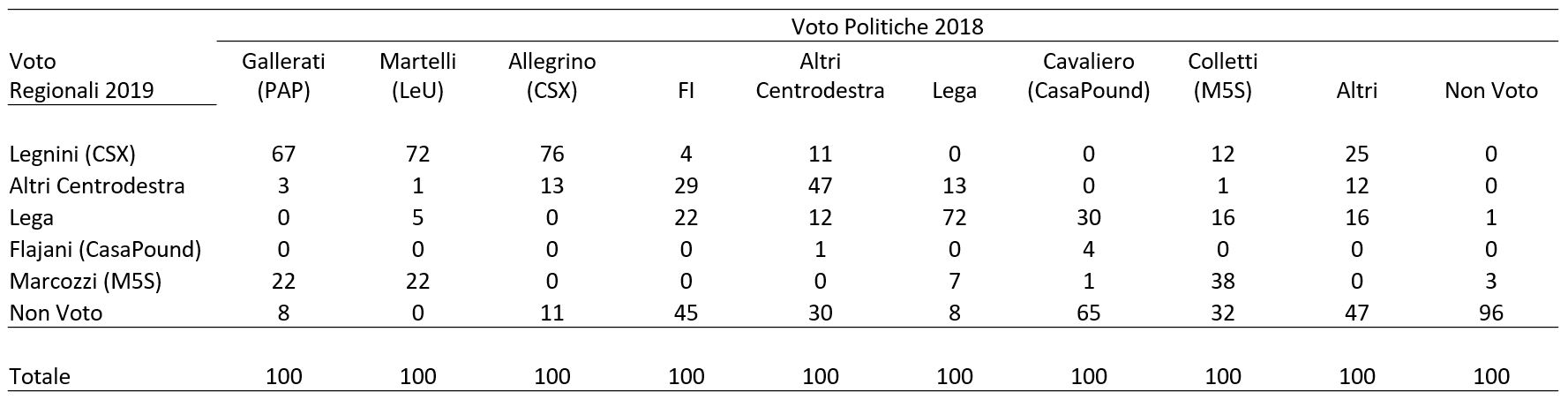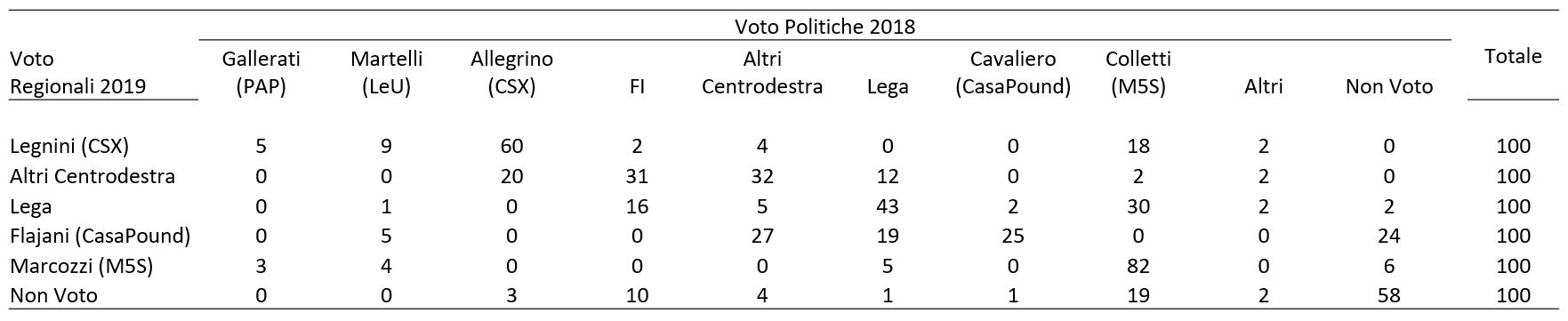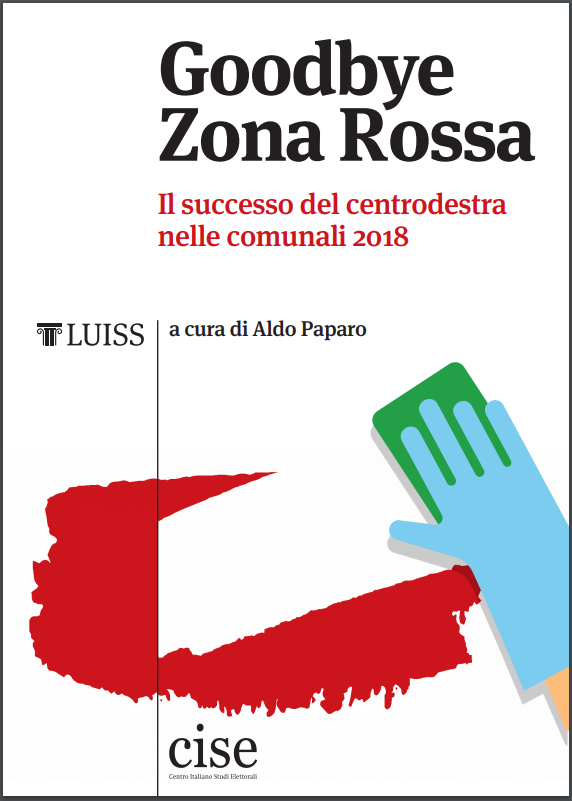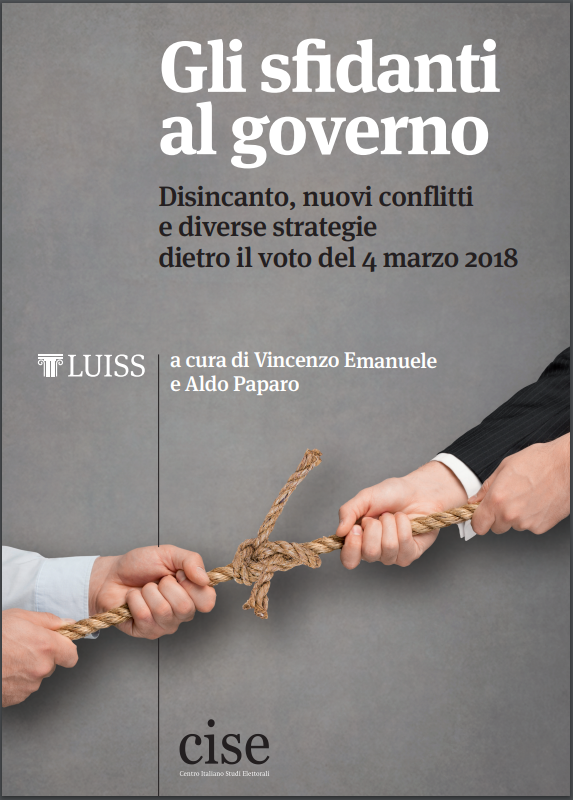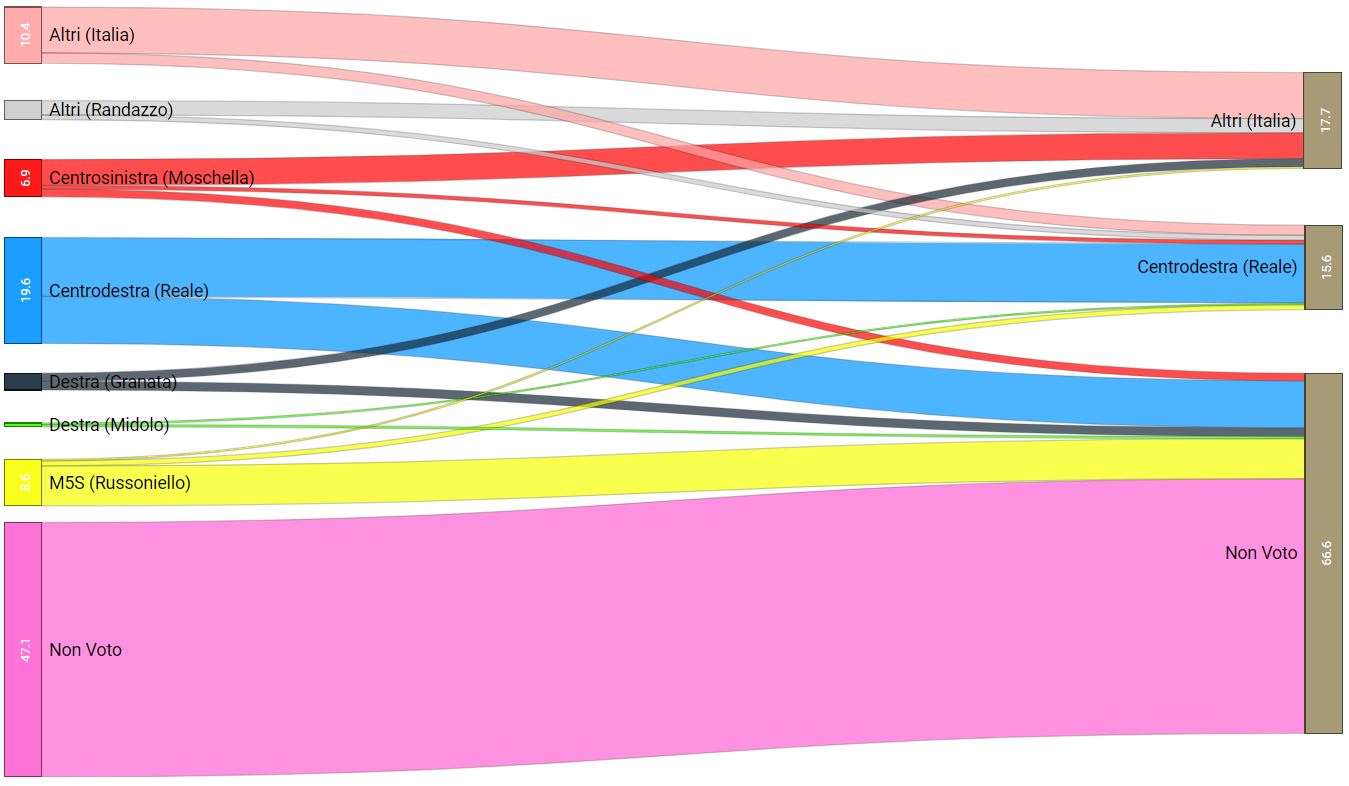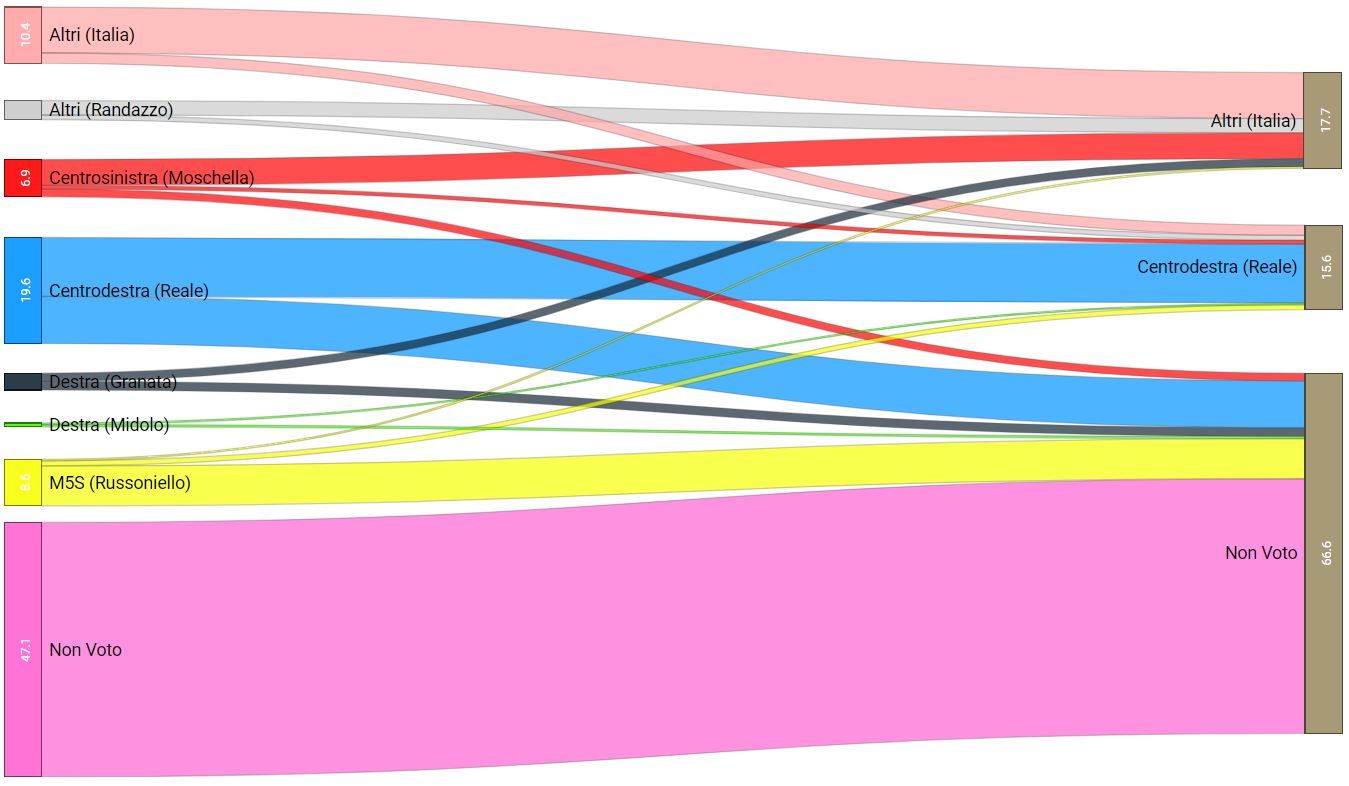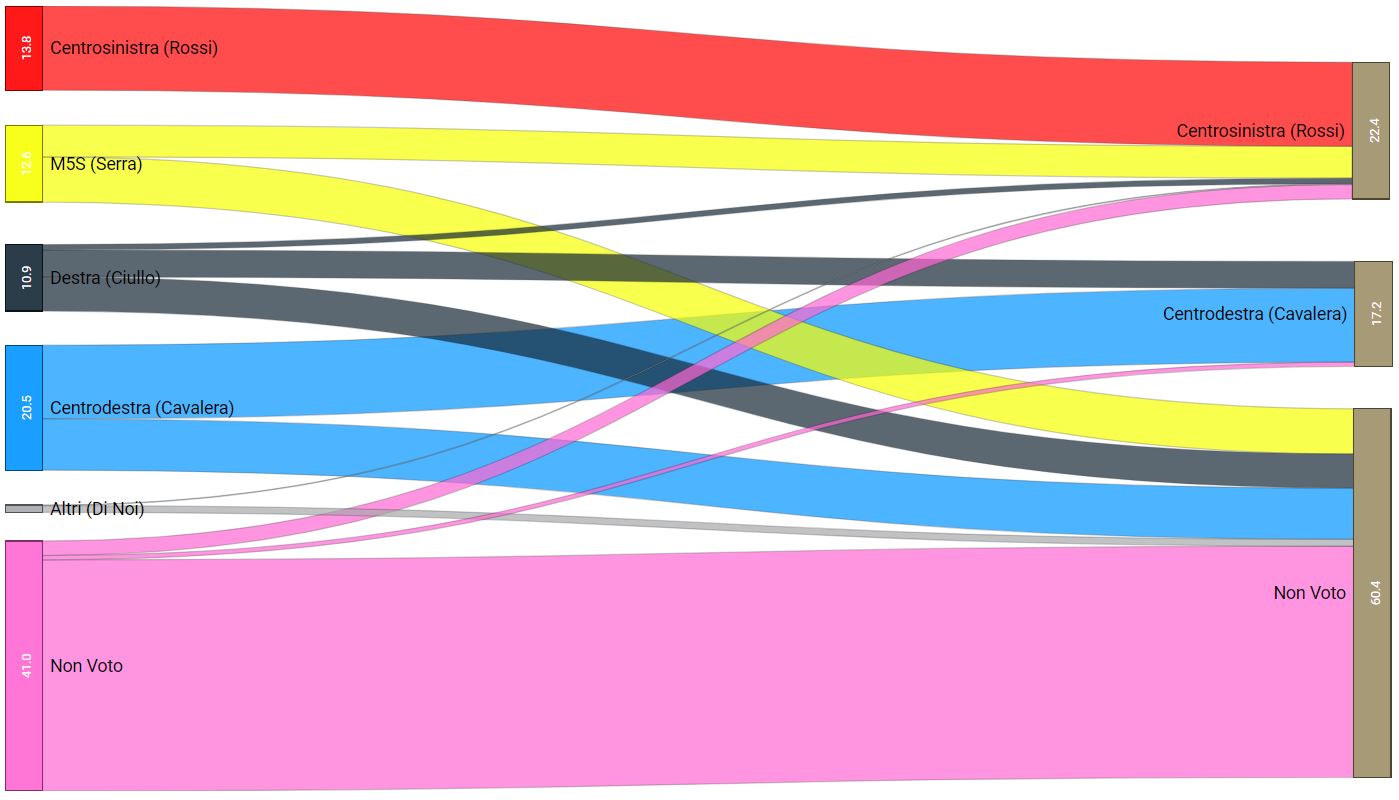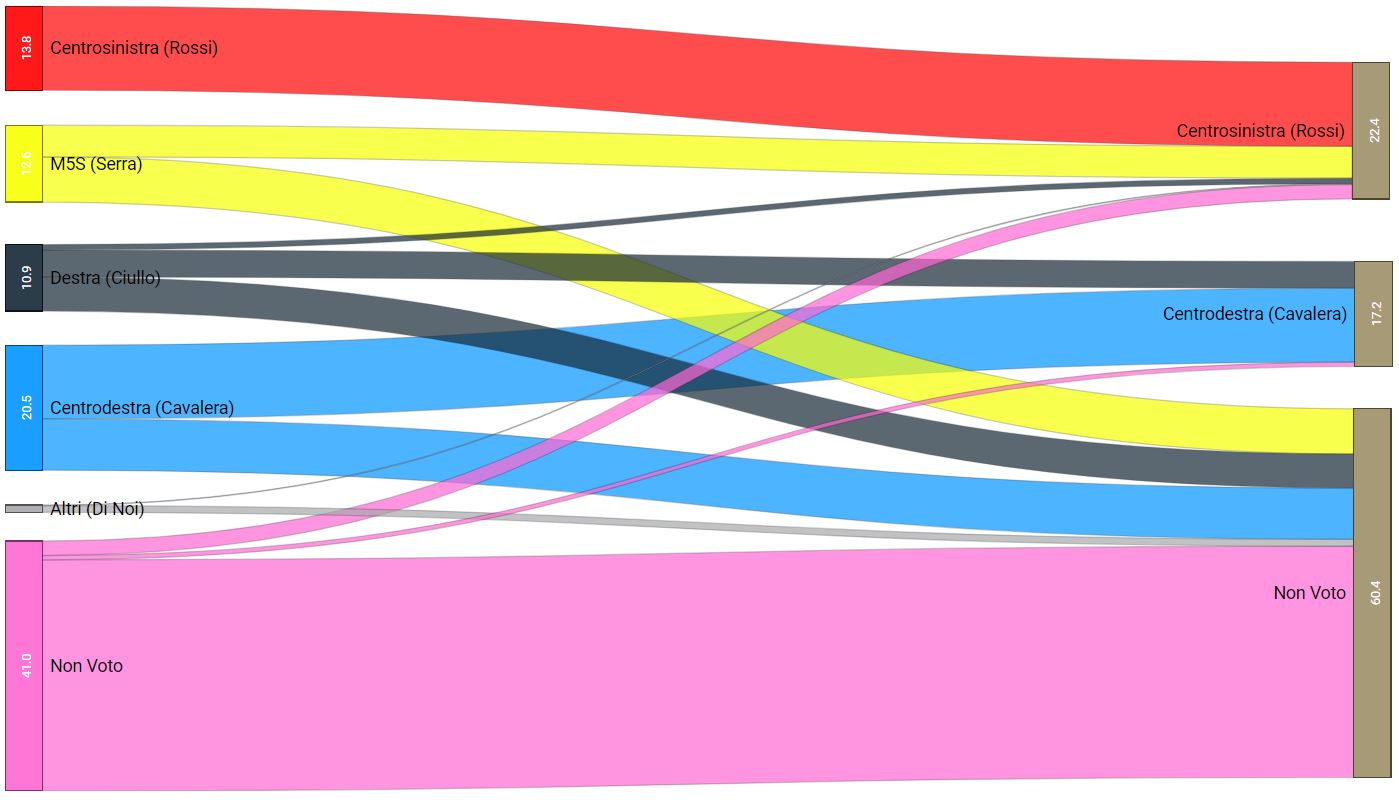Durante una pausa della conferenza Inside American Politics presso il campus di Firenze della New York University, il professor Tucker ha parlato con noi delle recenti elezioni (traduzione di Elisabetta Mannoni, il video originale in inglese è disponibile qui).
Joshua A. Tucker è professore di Politica, professore associato di Studi russi e slavi, e di Scienze dei dati presso la New York University. È direttore del Jordan Center for Advanced Study of Russia della NYU, co-direttore del laboratorio NYU Social Media e partecipazione politica (SMaPP) e coautore del premiato blog politico The Monkey Cage, pubblicato dal The Washington Post. Dal 2013 collabora con il CISE a studi sperimentali sugli effetti dell’identificazione di partito in Italia.
Professor Tucker, innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito a discutere le midterm elections con noi.
È un piacere.
Dunque, cosa è successo in queste elezioni? Conosciamo tutti i risultati; sappiamo cosa è successo al Senato, cosa alla Camera (Cuccurullo e Paparo 2018a) – ma quali sono, a suo avviso, le reali conclusioni da trarre? Cosa sta succedendo?
Credo ci siano due conclusioni fondamentali che possiamo trarre: la prima è che l’inasprimento degli Stati Uniti d’America in quanto realtà politica polarizzata si sta accentuando, un tema molto dibattuto in questi ultimi anni (Fiorina 2018). Una delle cose di cui si è discusso in questa conferenza è proprio il fatto che stiamo assistendo ad una fase in cui anche candidati deboli riescono ad ottenere grandi percentuali di voto, proprio perché le scelte di voto dei cittadini statunitensi dipendono sempre di più dal loro identificarsi come democratici o repubblicani e questa tendenza è in evidente aumento. Allo stesso tempo, assistiamo anche a quella che viene definita nazionalizzazione della politica statunitense, per cui notiamo una sempre maggiore congruenza tra chi viene eletto alle elezioni presidenziali e chi viene eletto al Congresso. In questo senso, c’è una strana somiglianza con il caso italiano: ci stiamo trasformando in un sistema parlamentare – anche se negli Stati Uniti il partito al governo ha appena perso alla Camera e questo in un sistema parlamentare significherebbe farsi da parte; tuttavia, negli Stati Uniti abbiamo questa strana formula delle elezioni legislative a metà mandato presidenziale, per cui può capitare che il partito al governo perda il controllo della Camera e rimanga comunque al governo, cosa che ovviamente non è ammissibile in un sistema parlamentare. Questo è il primo grande punto cruciale.
Il secondo è che abbiamo riscontrato una significativa e consistente avanzata del Partito Democratico. Per calare questo dato nell’immagine un po’ schematica che stiamo disegnando, possiamo dire che questo si è verificato principalmente nelle aree suburbane. I democratici sono tradizionalmente molto forti nelle città, i repubblicani nelle zone rurali. Quello che possiamo aggiungere è che stavolta nelle zone a metà tra le urbane e le rurali (zone storicamente repubblicane) c’è stato uno spostamento in direzione del Partito Democratico. In particolare, questo cambio di preferenze è avvenuto tra le donne con titolo di studio universitario, e ancora più in particolare tra le donne bianche con titolo di studio universitario – che se non erro avevano in maggioranza votato Trump alle elezioni 2016. Ora notiamo un gender gap che va aumentando progressivamente. Tendenzialmente le donne afro-americane rappresentano il gruppo più fortemente democratico, e a questo punto i repubblicani sono diventati ancora più impopolari anche tra le asioamericane e latinoamericane. L’America bianca è quella da cui Trump e il Partito Repubblicano ancora tendono ad attingere, per cui il fatto che abbiano perso il consenso di molte donne bianche con una laurea alle spalle costituisce un cambiamento molto significativo.
Un terzo punto cardine di queste elezioni è che ci troviamo ora in una situazione per cui – e questo forse è un concetto un po’ complesso per chi vive in un paese con un sistema proporzionale – i democratici, per ottenere il controllo della Camera dei Rappresentanti, devono vincere il voto popolare di almeno il 5 punti percentuali, e ci sono riusciti. Ma pensiamo un attimo a questo: se i Repubblicani avessero perso di 3 punti, avrebbero comunque mantenuto il controllo della Camera dei Rappresentanti. Da un punto di vista europeo, questo sarà probabilmente visto come una sorta di anatema, mentre in sistemi presidenziali ci troviamo spesso in situazioni anomale per cui il partito che è al governo non ha una maggioranza nel legislativo. Qui però parliamo della possibilità che addirittura un partito (quello Democratico) ottenesse la maggioranza dei voti e fosse comunque nella posizione di non poter governare. Questo è potenzialmente un gran problema nel lungo termine per gli Stati Uniti. Abbiamo già visto in due delle ultime cinque elezioni presidenziali che il partito che ha vinto il voto popolare non ha conquistato la Casa Bianca. I democratici hanno ottenuto la maggioranza in termini di voto popolare in quattro delle ultime cinque elezioni presidenziali, ma solo in due di questi casi sono riusciti anche a vincere la presidenza. Adesso abbiamo una situazione simile nella Camera dei Rappresentanti, dove per ottenerne il controllo i democratici dovevano vincere con uno stacco di almeno il 5 punti, mentre i repubblicani avrebbero potuto anche perdere di pochi punti.
Prima parlavamo dell’inasprimento della polarizzazione. Quello che non abbiamo detto è che la polarizzazione negli Stati Uniti ha una base geografica: una delle ragioni per cui i democratici devono vincere con un margine più ampio rispetto ai repubblicani è che i democratici sono molto più forti nelle città. Per cui, nel mio distretto, nel Greenwich Village a New York, i candidati democratici ottengono solitamente circa il 90% dei voti. Molti di quei voti però sono voti sprecati, perché non abbiamo un meccanismo compensativo come quello tedesco o quello ungherese: non c’è modo che i voti in eccesso possano avere un peso effettivo nella distribuzione dei seggi. Per cui, più aumenta il numero di liberal che si spostano nelle aree urbane, più alto sarà il numero di questi voti sprecati; e questo è un problema a lungo termine. E c’è anche un ulteriore fattore geografico che fa sì che i repubblicani possano ottenere più seggi vinti con il 60% o il 55% dei voti, mentre i democratici li vincono con percentuali più alte (come 80-90%). Mi riferisco al concetto del gerrymandering – altra cosa che suonerà folle all’orecchio di un europeo – che vede i partiti politici nella condizione di poter ‘disegnare’ i confini dei collegi, e di disegnarli in modo particolare, per cui poi si presentano casi come quello del North Carolina, dove pur avendo una distribuzione dei voti tale per cui il 50% dei cittadini vota democratico e l’altro 50% vota repubblicano, poi di fatto i democratici ottengono 3 seggi e i repubblicani 10. Lo stesso succedeva in Pennsylvania, ma qui i distretti stato sono stati ridefiniti quando la Corte Suprema ha definito illegale il gerrymandering che era stato operato. Da quel momento la Pennsylvania, altro Stato in cui i votanti si dividevano a metà tra repubblicani e democratici, è passata da una situazione in cui i repubblicani ottenevano 12 seggi contro i 6 dei democratici, ad una situazione di 9 seggi ciascuno – un risultato decisamente più in linea con un sistema proporzionale.
Infine, sempre nell’ambito di questa idea di disproporzionalità, c’è un altro problema a lungo termine, che ha a che fare con il Senato. Negli Stati Uniti, ogni Stato membro, a prescindere da quanto grande sia, ha diritto a due senatori. Questo si deve al compromesso fondativo raggiunto quando il paese fu istutuito, il cui scopo era bilanciare il voto popolare, che altrimenti avrebbe favorito gli stati più grandi tra quelli che avrebbero formato l’Unione, e costituire una federazione in cui i singoli stati fossero rappresentati in modo uguale (un po’ la stessa idea per cui il voto del Lussemburgo ha lo stesso peso di quello Germania nell’Unione Europea). Ora, uno dei problemi principali in questo senso è che, se guardiamo indietro nella storia, solitamente gli stati eleggevano senatori di partiti diversi, o comunque la distribuzione politica tra i vari stati cambiava molto da un periodo storico ad un altro. Adesso invece, in questo scenario politico che, come dicevamo prima, viaggia sostanzialmente su due schieramenti contrapposti, la situazione è tale per cui, di Stato in Stato, i due seggi al Senato sono spesso permanentemente associati ad un partito piuttosto che all’altro. E qui si ripropone la problematica legata alle grandi aree urbane, per cui in California (che conta 52 milioni di persone) i due senatori continueranno ad essere democratici anche nel prossimo futuro; stesso dicasi per lo stato di New York (con una popolazione di poco inferiore ai 20 milioni). Mentre poi ci sono altri piccoli stati rurali, come il North Dakota, il South Dakota, il Wyoming, l’Idaho, che hanno un numero infinitamente minore di abitanti, ma che ugualmente sono rappresentati da due senatori. E se storicamente c’era la possibilità che partiti diversi vincessero un diverso numero di seggi al senato in stati diversi, per come stanno le cose oggi, non è giusto che il voto di un abitante dello stato di New York valga 1/20 del voto di un abitante del Wyoming; eppure questo inevitabilmente ha avuto un forte impatto in termini di rappresentanza. Leggevo previsioni in merito al fatto che nel giro di vent’anni il 30% della popolazione degli Stati Uniti eleggerà di fatto il 50% dei senatori.
Penso che ci siano delle grandi domande da porsi in questo momento. Ancora di più se a questo aggiungiamo il fatto che Trump, da presidente, abbia diffuso comportamenti inediti, facendo cose che, seppur legali, non venivano comunque fatte; o che i anche i repubblicani in genere abbiano fatto lo stesso, come quando hanno negato di votare la conferma a un giudice della Corte Suprema nominato da Obama, dicendo che non avrebbero votato fino a dopo le elezioni (2016, ndr). Uno potrebbe dire – bene, se i repubblicani giocano sporco e in più ci sono condizioni strutturali che favoriscono i repubblicani, i democratici sono letteralmente svantaggiati dal sistema, ed è richiesto loro di raccogliere più voti di quelli che servirebbero ai repubblicani per ottenere la maggioranza. E infatti si comincia a notare che le persone stanno realmente iniziando a parlare di queste differenze. Non ricordo se fosse il New York Times o il Washington Post, ma uno dei due ha recentemente pubblicato un articolo in cui veniva detto che dovremmo aumentare le dimensioni della Casa dei Rappresentanti, cosa che non succede da cento anni negli Stati Uniti. Quello che forse potrebbe succedere, qualora un Presidente democratico tornasse alla Casa Bianca, sarebbe vederlo nominare giudici addizionali alla Corte Suprema. Di fatto non c’è nessuna regola scritta che voglia il numero dei giudici fisso a nove, per cui i democratici potrebbero lecitamente volerne di più, per riequilibrarne la composizione. O potrebbero venir messe in atto mosse per aumentare il numero degli Stati, per cui Puerto Rico o il District of Columbia potrebbero diventare stati a tutti gli effetti, per controbilanciare in parte il vantaggio strutturale che i repubblicani hanno sul Senato.
Si è parlato anche della potenziale nascita di due Californie, una California del Nord e una California del Sud, nel tentativo di aumentare la rappresentanza in Senato. Tutto questo è molto interessante. Noi avevamo condotto un’analisi prima delle elezioni, da cui risultava che la popolazione media dei 19 stati “rossi” era di circa 5 milioni, mentre quella 18 stati “blu” di 7,5 milioni (Cuccurullo e Paparo 2018b). Quindi fondamentalmente uno sconto del 50% sul costo in termini di elettori di ciascun senatore.
Esatto, e comunque c’è da notare che in certi casi la cosa può essere bidirezionale. Ora, senza entrare troppo nel merito del collegio elettorale per il Presidente, ma questa struttura potrebbe giocare a sfavore anche degli stessi repubblicani. Se il Texas (in cui, ricordiamoci, in queste elezioni la corsa per il Senato è stata molto più ravvicinate rispetto alla recente storia elettorale) passasse dall’essere uno Stato rosso ad essere uno Stato blu, e i democratici si trovassero durante le elezioni presidenziali in controllo della California, del Texas e dello stato di New York, comincerebbe ad essere piuttosto difficile pensare che i repubblicani possano effettivamente arrivare a conquistare una maggioranza dei grandi elettori ed eleggere quindi un loro Presidente.
Perciò, quello che possiamo concludere da tutto questo è che, da un lato, per come è strutturato, il sistema statunitense risulta essere estremamente proporzionale, nel senso che i partiti ottengono ciascuno più o meno la metà dei voti e a ciò corrisponde per ciascuno grossomodo la metà dei seggi; dall’altro sembra piuttosto ingiusto che i democratici debbano vincere di almeno 5 punti percentuali di margine nel voto popolare, quando lo stesso non è richiesto ai repubblicani. Certo, in confronto a paesi come la Polonia o la Russia, dove i partiti possono ottenere 1/3 dei voti e vederlo tradotto in 2/3 dei seggi, perché ci sono tantissimi partiti minori che non arrivano nemmeno in Parlamento, gli Stati Uniti possono considerarsi un paese proporzionale. Ma di fatto si tratta di un sistema come molte peculiarità: due soli partiti e collegi uninominali, che in generale presenta delle innegabili stranezze in merito a come i collegi vengono disegnati; il Senato, in particolare il modo in cui i seggi ad esso relativi sono assegnati e il potere che questo ha (esistono altri paesi che hanno una Camera Alta che rappresenta le regioni, ma di solito tendono ad essere più deboli rispetto alle camere basse); e infine il collegio elettorale presidenziale.
Riferimenti bibliografici
Cuccurullo, Davide e Aldo Paparo (2018a), ‘Elezioni di midterm: Trump perde la Camera ma avanza al Senato’. https://cise.luiss.it/cise/2018/11/14/elezioni-di-midterm-trump-perde-la-camera-ma-avanza-al-senato/
Cuccurullo, Davide e Aldo Paparo (2018b), ‘Oggi le elezioni di midterm: quali scenari per il Senato?’. https://cise.luiss.it/cise/2018/11/06/oggi-le-midterm-quali-scenari-per-il-senato/
Fiorina, Morris P. (2018), ‘È vero che democratici e repubblicani si odiano oggi più che mai?’. https://cise.luiss.it/cise/2018/11/05/e-vero-che-democratici-e-repubblicani-si-odiano-oggi-piu-che-mai/